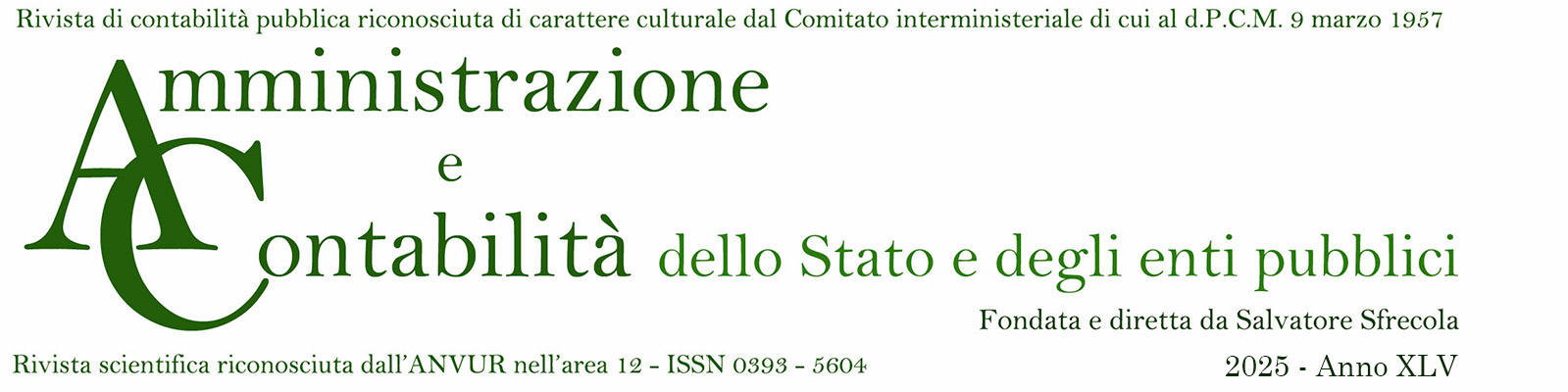Caro Direttore,
ho letto con interesse le considerazioni svolte dal Presidente Santoro, del quale ho sempre avuta altissima considerazione professionale, nell’articolo comparso sul numero più recente di Amministrazione e Contabilità dello Stato e degli enti pubblici, relativo al contenzioso insorto sulla decisione emessa dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria nel giudizio di parificazione del rendiconto della Regione per l’anno 2023.
La visione scientifica del Presidente Santoro è nota, per averla Lui espressa in molti scritti, tra i quali ricordo, proprio sulla medesima rivista, un articolo del dicembre 2019 sulla “deriva giustizialista” del controllo.
L’articolo più recente, dunque, è coerente con il percorso sin qui seguito e reca elementi non nuovi per l’Autore.
Tuttavia, questa volta, la lettura mi ha suscitato più riflessioni del consueto e Ti chiedo un po’ del prezioso spazio della rivista che dirigi per svolgerne due, di diverso segno:
la prima, di mero ordine tecnico;
la seconda relativa al ruolo che la Corte svolge (e, speriamo, continui a svolgere) nel nostro assetto istituzionale.
Quanto alla prima, ho registrato che l’Autore ha del tutto evitato di confrontarsi con l’approdo cui sono pervenute le SS.RR. della Corte dei conti in speciale composizione con la sentenza n. 7/2022/DELC, affermando che “oggetto del giudizio di parificazione è la legalità del rendiconto generale dell’esercizio e, quindi, del correlato risultato di amministrazione”, con “funzione «accertativa», di riscontro della conformità – in termini di regolarità–legittimità – dei «fatti» contabili rappresentati nel rendiconto rispetto ai parametri costituzionali ed alle norme dell’ordinamento giuridico-contabile vigenti nell’esercizio analizzato. L’esito di tale attività di riscontro è contenuto nell’ambito di una «decisione», equiparabile negli effetti e, quindi, nella forma e nella sostanza, ad una sentenza, in quanto accerta e dichiara con una pronuncia di tipo dicotomico – esclusivamente sulla base di parametri normativi – la legittimità o meno del rendiconto e dei correlati effetti sul risultato di amministrazione e, quindi, la sua parificazione o non parificazione. L’accertamento effettuato «fa stato» nei confronti delle parti, una volta decorsi i termini di impugnazione” (enfasi aggiunta). Resta proprio della fase di controllo (sub specie di controllo/referto) la relazione che la Sezione di controllo emette sul disegno di legge di rendiconto della Regione e che costituisce, al tempo stesso, la delimitazione del thema decidendum.
Ne deriva che l’affermazione dell’Autore, per la quale “la parificazione del rendiconto generale (che sia dello Stato o della Regione)è un procedimento esclusivamente ascrivibile alla funzione del controllo, che nulla ha a che vedere con l’attività giurisdizionale”, non solamente contraddice l’antica (1934) regola delle forme contenziose della sua celebrazione, in quanto “giudizio”, ma è oramai fuori dalla storia e non corrisponde più all’evoluzione cui la materia è stata sottoposta con le norme del 2011/2012 e con le plurime pronunzie della Corte costituzionale, segnatamente a seguito delle coeve modificazioni degli articoli 81 e 97 e di quelle più risalenti (2001) del Titolo V della Carta fondamentale. Non cogliere il mutato assetto ordinamentale che ne è derivato, soprattutto per i profili finanziari connessi, significa difendere un ordine dei rapporti finanziari e contabili oramai fuori dalla storia.
La menzionata sentenza delle Sezioni Riunite ha il pregio di collocare – finalmente – il giudizio di parificazione nel suo esatto ambito rispetto alla dinamica in atto tra Corte dei conti ed Amministrazioni in materia di controllo contabile e di difesa dei valori della finanza pubblica, nell’interesse della Comunità di riferimento, da collocare indefettibilmente nella corretta gestione delle risorse disponibili, per definizione scarse.
Questa sottolineatura introduce alla seconda considerazione che desidero qui svolgere.
L’Autore richiama la legge di Gresham (“la moneta cattiva scaccia quella buona”) riferendosi, nella circostanza, ad argomenti tutti processuali, che non dà conto qui riportare, essendo chiarissimi nel testo dell’articolo.
Non sto a commentare la questione della veste che il P.M. contabile assume nel giudizio di parificazione, se esso sia parte o interventore necessario: sul punto mi limito a registrare che il P.M. contabile medesimo, nei giudizi ad istanza di parte, è certamente interventore necessario e non parte; mai, però, ne è stata contestata la legittimazione a gravarsi di decisioni nelle quali abbi scorto, a torto o a ragione, profili critici rispetto alla tutela imparziale dell’interesse generale in materia di finanza pubblica, che gli compete per dovere d’ufficio.
Registro, però, una fondamentale diversità di punti di vista sul punto: la “moneta cattiva”, a mio sommesso modo di vedere, non risiede nelle asserite distorsioni dei ruoli processuali e dei rispettivi poteri d’intervento denunziati dall’Autore. Essa alberga, invece, nell’incapacità di utilizzare gli strumenti messi a disposizione dall’ordinamento a tutela degl’interessi adespoti dei quali il Procuratore contabile ha l’obbligo di occuparsi, con ogni mezzo e risorsa, anche ove – come nel caso del giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Liguria per l’anno 2023 – la “sensibilità” della Sezione di controllo locale non sia pervenuta ad assicurarne essa stessa la cura, implicando, con l’assunzione di una decisione francamente sconcertante, la necessità di interpellare una superiore sede.
Ti ringrazio ancora per lo spazio concessomi.
Con grande stima,
Roberto LEONI – Procuratore regionale della Corte dei conti per la Liguria