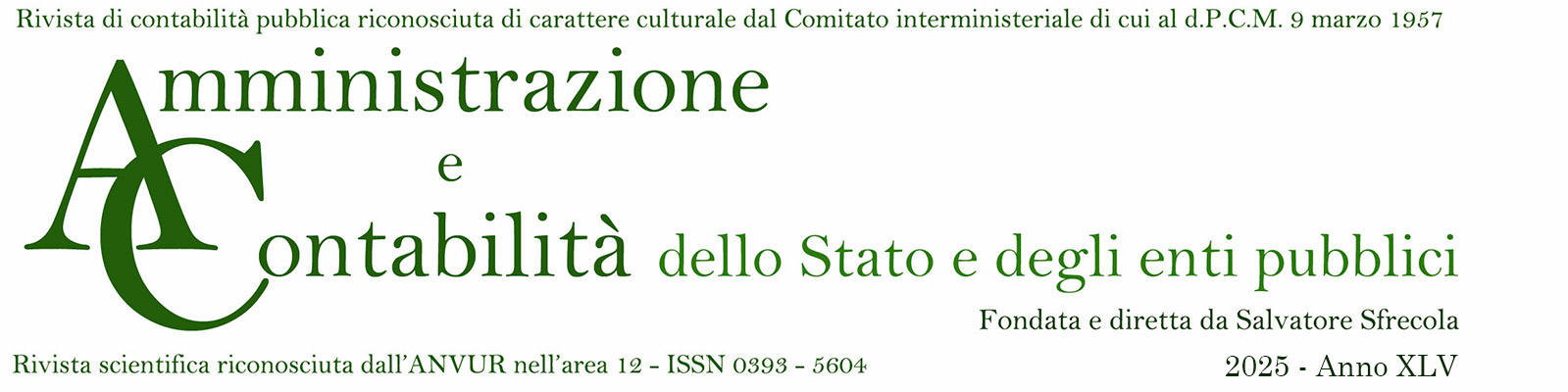di Alessandra Vanacore, Assegnista di Ricerca Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli studi della Campania “L. Vanvitelli”
Abstract
Nel contesto attuale, l’interesse collettivo è focalizzato su forme di turismo che possono garantire al contempo un equilibrio tra crescita economica e tutela degli ecosistemi. Si sviluppano, dunque, diverse attività turistiche sostenibili, volte a minimizzare gli impatti del settore sull’ambiente e sulle comunità locali.
Le aree protette assumono una particolare rilevanza, rappresentando laboratori per l’applicazione pratica dei principi di sviluppo sostenibile, ma anche il luogo ideale per lo svolgimento di esperienze autentiche e rispettose della natura.
Con l’obiettivo di individuare le migliori pratiche per conciliare lo sviluppo economico del settore con la tutela dell’ambiente risulta fondamentale lo studio dell’impatto del quadro normativo internazionale ed europeo sul turismo e il confronto tra le strategie adottate in Paesi diversi, nello specifico in Italia e in Spagna, per osservare differenti modelli di governance del settore turistico e delle aree protette.
Sommario: 1. I principi e le definizioni del turismo sostenibile; – 2. Il quadro normativo internazionale ed europeo sul turismo sostenibile e sulla gestione delle aree protette; – 3. La governance del turismo sostenibile in Italia e Spagna; – 4. Conclusioni.
1. I principi e le definizioni del turismo sostenibile
La crescente consapevolezza riguardo gli effetti delle attività umane sull’ecosistema ha portato turisti ed imprese del settore a adottare pratiche sempre più responsabili.
Fino a qualche decennio fa, il turismo era considerato un fenomeno in grado di svilupparsi autonomamente, senza la necessità di interventi di controllo o programmazione[1]. Tuttavia, a partire dagli anni Settanta del XX secolo, è emerso il forte impatto del turismo sull’ambiente, dovuto principalmente allo sviluppo dell’industria dei trasporti e alla conseguente maggiore facilità di spostamento dei passeggeri a livello globale.
Nel 1980, l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OECD), grazie all’istituzione di un gruppo di lavoro, istituito nel 1977 con il fine di studiare ed individuare strategie per la mitigazione degli impatti negativi del turismo sull’ambiente, ha pubblicato delle linee guida per favorire l’informazione e l’educazione sulla tutela ambientale nel settore. Queste linee guida hanno favorito l’adozione di strumenti di pianificazione e gestione del turismo sostenibile nei Paesi membri.
In seguito, il Consiglio per l’Ambiente e il Turismo dell’OECD, si è occupato di approfondire anche l’aspetto economico, fornendo informazioni più articolate e integrate per la gestione del settore[2].
Questi temi risultano particolarmente rilevanti in considerazione dei benefici derivanti da scelte più sostenibili, i quali si traducono, non solo in una protezione delle risorse naturali e culturali e, dunque, in una prospettiva volta anche agli interessi delle generazioni future, ma anche in un arricchimento dell’esperienza di viaggio, in quanto la scelta di un turismo più sostenibile, offre la possibilità di scoprire luoghi autentici e incontaminati.
Con la crescita del turismo e il conseguente sviluppo del turismo di massa c’è stata, infatti, anche una maggiore ricerca da parte dei turisti di forme di turismo rispettose dell’ambiente e delle tradizioni delle destinazioni visitate[3].
Il turismo diviene, dunque, uno strumento di sensibilizzazione e di promozione della sostenibilità, favorendo lo sviluppo di modelli che possono salvaguardare la qualità di vita delle comunità ospitanti[4].
In particolare, il turismo sostenibile fonda le sue radici su principi di responsabilità sociale ed ambientale e su un approccio che possa integrare lo sviluppo economico delle comunità ospitanti, il loro benessere sociale e la valorizzazione delle realtà locali. In questo contesto, assume un ruolo fondamentale, inoltre, la protezione dell’ambiente attraverso una gestione equilibrata delle risorse naturali.
Già nel 1985, Claus-Dieter Hetzer[5] aveva individuato quattro direttrici fondamentali per mitigare l’impatto del turismo: la riduzione del danno ambientale, il rispetto e la valorizzazione delle culture e delle tradizioni locali, lo sviluppo di benefici economici per le comunità ospitanti e la soddisfazione dei turisti[6].
Una prima definizione di turismo sostenibile è stata, successivamente, fornita dall’Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT), che lo descrive come: «Turismo che tiene pienamente conto dei suoi impatti economici, sociali e ambientali attuali e futuri, rispondendo alle esigenze dei visitatori, dell’industria, dell’ambiente e delle comunità ospitanti»[7].
Questa definizione è basata sui principi contenuti nel Rapporto Brundtland, risalente al 1987, il quale, si concentra, in particolare, sul concetto di sviluppo sostenibile. Secondo il Rapporto, questo consiste in: «uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri».
In linea con questa visione, l’OMT ha evidenziato che la crescita sostenibile del numero di visitatori in una destinazione non dovrebbe più rappresentare il principale criterio di sviluppo del settore turistico. Al contrario, è fondamentale adottare un approccio integrato che favorisca la tutela dell’ambiente, assicuri benefici concreti per le comunità locali e contribuisca alla conservazione del patrimonio culturale delle destinazioni turistiche.
Diversi sono stati gli studiosi che nel tempo hanno approfondito il tema della sostenibilità nel contesto turistico. In particolare, in dottrina si ritrovano due principali interpretazioni di tale concetto: da un lato, gli studiosi concentrano la loro attenzione sul concetto di capacità di carico turistico, intesa come
il numero massimo di visitatori che una destinazione può accogliere in un determinato periodo senza compromettere l’ambiente, né gli aspetti economici, sociali e culturali delle comunità locali e senza ridurre la qualità dell’esperienza del turista[8]. Questa prima visione assume rilevanza soprattutto nel contesto delle aree naturali protette, dove è necessaria una gestione attenta e conteggiata dei visitatori per tutelare le specificità del territorio[9].
Dall’altro lato, esiste un’interpretazione più flessibile, incentrata sul rispetto per l’ambiente economico e sociale, sebbene il concetto di “rispetto” rimanga piuttosto vago e suscettibile di diverse interpretazioni, specialmente da parte dei promotori di progetti turistici che tendono a adeguare il proprio linguaggio alle tendenze del momento e a negoziare con vari interlocutori istituzionali[10].
Una definizione che riesce a conciliare entrambi gli approcci descrive il turismo sostenibile come un insieme di pratiche ispirate ai principi della conservazione, finalizzate alla valorizzazione e alla tutela delle risorse di un territorio, siano esse naturali, culturali o sociali, con l’obiettivo di accogliere i visitatori riducendo al minimo gli impatti negativi inevitabilmente associati all’attività turistica.
Lo sviluppo del turismo sostenibile comporta l’adattamento del quadro normativo e degli strumenti di pianificazione per garantire un equilibrio tra la conservazione del patrimonio naturale e culturale, la sostenibilità economica del settore e l’equità sociale.
Le linee guida per uno sviluppo sostenibile del turismo devono applicarsi a tutte le forme e destinazioni turistiche, stabilendo un equilibrio tra la dimensione ambientale, economica e socioculturale.
Accanto al turismo sostenibile, si sviluppano altre forme di turismo, sempre orientate alla sostenibilità ma con una maggiore focalizzazione su specifici valori e pratiche.
Tra le forme di turismo sostenibile, l’ecoturismo viene definito dall’International Union for Conservation of Nature (IUCN), come una forma di turismo che si concentra sulle aree naturali, attraverso visite che ne valorizzano il paesaggio, la biodiversità, minimizzando gli impatti negativi. Questo, dunque, si configura come una pratica che integra la valorizzazione ambientale con la protezione del patrimonio naturale e culturale, favorendone attivamente la conservazione[11]. Questa tipologia di turismo include realtà variegate, talvolta sovrapponibili anche al turismo naturalistico[12] o d’avventura[13].
Tra le altre tipologie, si ritrova, inoltre, il turismo etico e responsabile, che condividono con l’ecoturismo una prospettiva di sostenibilità, ma si concentrano in modo più specifico sui comportamenti e sulle pratiche adottate dai turisti e dagli operatori del settore. Il loro obiettivo è promuovere un’interazione con le comunità locali e la tutela dell’ambiente, favorendo una maggiore sensibilizzazione nei confronti delle problematiche socio-ambientali legate al turismo.
Queste forme di turismo sostenibile, che si fondano sulla preservazione delle risorse naturali e culturali, trovano nelle aree naturali protette un pilastro fondamentale.
Le aree protette sono spazi geografici che possiedono caratteristiche ecologiche, biologiche, culturali o paesaggistiche di particolare valore, e che necessitano di una protezione speciale per garantirne l’integrità, in particolare in relazione alla resilienza agli impatti dei cambiamenti climatici[14].
Nel 1872 è stata istituita la prima area protetta con la creazione del Parco Nazionale di Yellowstone, negli Stati Uniti[15].
Le aree protette nel mondo hanno poi subito una crescita esponenziale, a partire dal periodo intercorso tra le due guerre mondiali e successivamente, tra gli anni Cinquanta del XX secolo e i primi anni Duemila[16].
L’International Union for the Conservation of Nature (IUCN), enunciata nel 1994 e poi aggiornata nel 2008, costituisce un importante punto di riferimento per le aree naturali protette. Questa le definisce come spazi geografici chiaramente delimitati, riconosciuti, dedicati e gestiti, attraverso strumenti giuridici o altri mezzi efficaci, che hanno l’obiettivo di garantire la conservazione della natura nel lungo periodo.
Un’area protetta si caratterizza, in particolare, attraverso tre aspetti: quello spaziale, quello normativo e quello teleologico. Nel primo caso, si fa riferimento alla necessità di individuare specificatamente l’area in questione all’interno di un determinato territorio; dal punto di vista normativo, devono essere considerati tutti gli strumenti giuridici atti a riconoscere giuridicamente l’area come area protetta e a garantire la tutela della stessa attraverso una gestione adeguata; infine, l’aspetto teleologico si riferisce allo scopo dell’area protetta e, dunque, alla conservazione e alla valorizzazione della stessa.
Proprio in riferimento all’aspetto teleologico, è bene considerare che le aree protette svolgono un ruolo significativo, non solo dal punto di vista della tutela ambientale, ma anche per aspetti culturali, sociali ed economici. Infatti, queste consentono la promozione di esperienze turistiche che favoriscono l’educazione ambientale, la ricerca scientifica e lo sviluppo di un turismo rispettoso delle comunità locali[17]. Le attività turistiche possono, dunque, contribuire alla crescita economica e culturale delle località nelle quali vengono svolte, se adeguatamente gestite. In tal senso, è fondamentale l’adozione di piani che, anche attraverso la partecipazione delle popolazioni locali, favoriscano il rispetto delle destinazioni e gestiscano il sovraffollamento turistico.
Dunque, la sinergia tra conservazione e sviluppo sostenibile rappresenta un elemento fondamentale per garantire un futuro resiliente per il turismo e per i territori protetti, assicurando così la loro sostenibilità a lungo termine.
2. Il quadro normativo internazionale ed europeo sul turismo sostenibile e sulla gestione delle aree protette
Nel contesto del dibattito sullo sviluppo sostenibile, il turismo è stato precocemente coinvolto per le sue implicazioni ambientali e socio-economiche.
L’urbanizzazione incontrollata delle aree turistiche, sviluppatasi negli anni ’60[18], ha suscitato le prime campagne di sensibilizzazione sul tema, poiché gli impatti negativi di un turismo di massa non regolato divennero evidenti.
Di conseguenza, numerose politiche e regolamenti sono stati formulati a livello internazionale, in particolare, grazie al lavoro dell’Organizzazione Mondiale del Turismo che ha posto le basi per la definizione di principi fondamentali afferenti al turismo sostenibile. Tuttavia, anche a livello europeo sono state introdotte iniziative incentrate su un turismo responsabile e sostenibile, in linea con le iniziative di riduzione delle emissioni e del raggiungimento della neutralità climatica e in risposta a una maggiore consapevolezza sull’impatto del turismo sull’ambiente.
Un primo passo verso la creazione di un quadro normativo internazionale sul tema del turismo sostenibile si deve alla Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo, tenutasi a Rio nel 1992[19], che, pur non essendo incentrata specificatamente sul settore turistico, ha contribuito in maniera importante all’adozione di strategie mirate al consolidamento di un equilibrio tra sviluppo economico, tutela ambientale e benessere sociale[20].
Successivamente, la Carta del Turismo Sostenibile[21], redatta a seguito della Conferenza Mondiale sul Turismo Sostenibile di Lanzarote nel 1995, ha riportato il tema della sostenibilità nel contesto del turismo, attraverso diciotto principi fondamentali. In particolare, questa con il coinvolgimento di attori e di organizzazioni del settore e della partecipazione delle comunità locali, ha portato l’attenzione sulle principali criticità del settore turistico e, di conseguenza, sulla necessità di integrazione tra attività turistiche e destinazioni, sull’importanza del rispetto da parte dei turisti per le tradizioni locali e sulla necessità di una ponderazione tra i benefici e i costi derivanti dalle attività turistiche. Dunque, la Carta richiede agli Stati l’adozione di strumenti (politici, economici, giuridici e fiscali) atti a consentire uno sviluppo sostenibile del settore.
Un ulteriore contributo normativo rilevante è rappresentato dall’Agenda 21 per l’Industria dei Viaggi e del Turismo, documento sviluppato nel 1995 dal World Travel & Tourism Council (WTTC), dall’OMT e dal Consiglio della Terra. Questo documento, ispirandosi ai principi dell’Agenda 21, adottata in seguito alla Conferenza di Rio, stabilisce un codice di condotta per gli operatori e i consumatori del turismo, individuando aree prioritarie di intervento quali la gestione sostenibile dei rifiuti, il risparmio energetico, la tutela delle risorse idriche e il controllo delle sostanze pericolose[22].
Inoltre, l’Agenda si occupa di coinvolgere e far cooperare tra loro attori istituzionali ed economici a livello globale per favorire un’adozione più agile e centralizzata delle strategie legate al turismo sostenibile.
Nel 1999, è stato approvato dall’OMT il Codice Etico Mondiale per il Turismo, il cui principale obiettivo è promuovere un turismo responsabile e sostenibile, accessibile a tutti e in armonia con i principi del libero mercato. In questo contesto, vengono sottolineati il diritto al turismo e alla libertà di movimento turistico, oltre all’impegno a sostenere un ordine turistico globale che sia equo, responsabile e sostenibile, capace di generare benefici reciproci per tutti i settori della società in un’economia internazionale aperta e liberalizzata.
Il Codice contiene dieci principi, non vincolanti dal punto di vista legale, ma che, di fatto, esercitano un’influenza notevole sulle scelte politiche adottate dagli Stati.
I principi riguardano, in particolare, aspetti quali l’importanza della comprensione reciproca tra i popoli, lo sviluppo della collettività, il rilancio del patrimonio culturale, ma anche aspetti legati all’ambito della sostenibilità ambientale. In riferimento a questo tema, assume, infatti, rilevanza l’articolo 3, nel quale il turismo viene collocato come un fattore chiave per la protezione delle risorse naturali e della biodiversità. Forme di turismo, come quello naturale o l’ecoturismo, implicano infatti l’impegno da parte dei turisti di proteggere le risorse visitate e la responsabilità degli operatori di considerare la capacità di accoglienza di ciascuna destinazione.
Più di recente, nel 2021, durante la Conferenza delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (COP26) è stata prodotta la Dichiarazione di Glasgow, relativa all’azione per il clima nel turismo[23].
La Dichiarazione, allineandosi agli obiettivi globali di neutralità carbonica al 2050, prevede, nello specifico, la riduzione delle emissioni di gas serra nel settore turistico, attraverso la cooperazione tra attori istituzionali, attori turistici e della società civile[24]. Questo obiettivo può essere perseguito con l’adozione e l’attuazione di piani di azione climatica da parte dei Paesi firmatari, i quali sono obbligati a riferire annualmente sui progressi ottenuti[25].
Nel contesto internazionale, dunque, diverse sono le iniziative relative a un turismo sostenibile. In questa circostanza, anche l’Unione Europea, consapevole dell’importanza di affrontare le sfide globali in maniera coesa, gioca un ruolo importante.
A livello europeo, infatti, si è delineato progressivamente un quadro normativo che, sulla base delle linee guida internazionali, è volto ad integrare la sostenibilità con le peculiarità del settore turistico, adattandosi anche alle necessità più specifiche dei singoli territori.
Ricostruendo l’evoluzione del quadro legislativo europeo, un primo processo di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità si è avuto tra gli anni 1992-2000, con il V Programma Comunitario per l’Ambiente e il Turismo Sostenibile, che ha introdotto le questioni ambientali in tutte le politiche dell’Unione, attraverso le Agende 21 settoriali.
In seguito, ci sono stati politiche e progetti dedicati più nello specifico al settore turistico, non solo per la sostenibilità, ma anche per un miglioramento della conoscenza del settore e del rafforzamento dello stesso. Infatti, la Commissione Europea ha presentato il programma Philoxenia[26], che prevedeva, innanzitutto, un sistema statistico, basato su indagini e studi, per raccogliere e analizzare i dati del settore e, di conseguenza, la creazione di una documentazione di base che gli Stati membri potessero condividere e studiare. Questo ha portato ad un’evoluzione delle norme di settore, con regolamenti più favorevoli al turismo ed incentivi che hanno favorito una maggiore mobilità dei turisti, anche dai Paesi terzi, attraverso una maggiore promozione dell’Europa come destinazione turistica. Il programma insieme con, il Libro Verde sul turismo, delineato sempre in quegli anni (nel 1995), si concentrava, inoltre, sul tema della sostenibilità, attraverso strategie mirate, iniziative locali rispettose degli ecosistemi e programmi di educazione ambientale per turisti e operatori.
Altra tappa importante per l’evoluzione del quadro normativo europeo sul turismo sostenibile si è registrata nel 2007 con l’Agenda per un Turismo Europeo Sostenibile e Competitivo[27] e il progetto “Destinazioni Europee per l’Eccellenza” (EDEN)[28]. In questo contesto, infatti, sono cambiate le modalità di approccio alla questione e gli studiosi hanno iniziato ad applicare nuove metodologie per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. In particolare, si è sviluppato un approccio integrato che tenesse conto anche degli aspetti economici, oltre che di quelli ambientali, basato sulla convinzione che la competitività sia strettamente legata alla sostenibilità. Si è compresa, inoltre, l’importanza della pianificazione strategica a lungo termine e del coinvolgimento delle parti interessate.
I principali obiettivi di sostenibilità dell’Agenda riguardano la conservazione delle risorse naturali, la corretta gestione dei beni culturali e la lotta alla stagionalità turistica. Il progetto EDEN ha poi ripreso questi obiettivi riportandoli nelle attività di valorizzazione delle destinazioni turistiche.
Successivamente, questi temi sono stati inseriti nella Dichiarazione di Madrid del 2010, che ha integrato i modelli di turismo sostenibile e responsabile con l’uso di tecnologie, allargandoli anche ad altri settori collegati a quello turistico, come quello dei trasporti.
Questo impegno è stato ripreso e rafforzato, più di recente, nel 2022, con l’adozione dell’Agenda Europea per il Turismo 2030 da parte del Consiglio dell’Unione Europea. L’Agenda riguarda, infatti, gli obiettivi e i temi, già presentati nel 2007 sviluppandoli attraverso cinque linee d’azione: transizione verde, transizione digitale, resilienza e inclusione, competenze e supporto, e un quadro politico e di governance abilitante.
Il quadro normativo europeo, dunque, si caratterizza per un’evoluzione costante verso un modello di turismo che coniuga crescita economica, equità sociale e tutela ambientale e che mira a garantire una crescita equilibrata del turismo europeo, assicurando benefici duraturi per le comunità locali e per l’ambiente.
In questo contesto normativo, le aree protette rappresentano non solo un obiettivo di conservazione, ma anche un laboratorio pratico in cui il turismo sostenibile può essere messo in atto concretamente.
Le prime forme di turismo sostenibile si sono, infatti, sviluppate principalmente nelle aree protette, ovvero quei territori che, grazie alle loro caratteristiche ecologiche, paesaggistiche e culturali, si sono rivelati essere i luoghi ideali per l’attuazione di pratiche responsabili[29].
Ancora oggi, nonostante la diffusione di attività turistiche sostenibili, come l’ecoturismo, il turismo naturalistico e d’avventura, diffuse in qualsiasi tipo di destinazione turistica, le aree protette continuano a costituire il fulcro del turismo sostenibile[30]. È proprio in queste aree, infatti, che si concentrano gli sforzi per la protezione della biodiversità e degli habitat naturali.
Nel corso degli ultimi decenni, il riconoscimento dell’importanza della protezione ambientale ha portato alla formulazione di numerosi strumenti giuridici e strategie operative, che hanno progressivamente delineato un sistema in grado di integrare gli interessi delle comunità locali, degli Stati e della comunità internazionale. Tali strumenti hanno contribuito a creare una rete globale di aree protette, in cui il valore ecologico, economico e culturale degli ecosistemi è riconosciuto e tutelato.
Tra i primi strumenti internazionali dedicati a questo ambito, la Convenzione di Ramsar, adottata nel 1971, ha posto le basi per la conservazione e l’uso sostenibile delle zone umide di rilevanza internazionale, creando una rete di siti caratterizzati da un valore ecologico riconosciuto a livello globale. La sua adozione ha segnato l’inizio di una crescente consapevolezza circa la fragilità di tali ambienti e la necessità di una gestione coordinata a livello internazionale, coinvolgendo non solo gli Stati ma anche numerose istituzioni scientifiche e organizzazioni non governative.
Un ulteriore tassello fondamentale nel complesso quadro normativo internazionale è rappresentato dalla Convenzione sul Patrimonio Mondiale[31], istituita nel 1972 sotto l’egida dell’UNESCO. Tale convenzione non si limita a tutelare soltanto il patrimonio culturale, ma estende la sua protezione anche alle aree naturali. I siti riconosciuti come Patrimonio Mondiale sono considerati beni comuni dell’umanità e, pertanto, richiedono un regime di protezione che ne garantisca la conservazione per le generazioni future.
Successivamente, la Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD), adottata nel 1992 durante la Conferenza di Rio, ha ampliato il quadro giuridico, comprendendo anche la tutela della biodiversità. La Convenzione si prefigge, infatti, di garantire la conservazione della varietà di forme di vita presenti sul pianeta, stabilendo che la protezione delle aree naturali e la creazione di reti di aree protette rappresentino strumenti indispensabili per raggiungere tale obiettivo.
Nel 2003, la Strategia Globale per la Conservazione delle Aree Protette e il Programma di Aree Protette dell’International Union for Conservation of Nature (IUCN) hanno segnato un fondamentale avanzamento nella tutela degli ecosistemi.
La prima ha definito obiettivi condivisi e buone pratiche per rafforzare la rete globale, integrando politiche per contrastare il cambiamento climatico, le pressioni antropiche e la scarsità di risorse, mentre il secondo ha consolidato il ruolo delle organizzazioni internazionali.
Negli anni più recenti, ulteriori documenti e strategie hanno rafforzato il quadro normativo internazionale, sottolineando la necessità di un approccio integrato e multidisciplinare, evidenziando come la protezione della natura debba essere considerata una priorità, non solo per la conservazione della biodiversità, ma anche per il mantenimento dei servizi ecosistemici essenziali al sostentamento umano, quali la regolazione del clima, la purificazione dell’aria e dell’acqua e la protezione contro eventi meteorologici estremi.
In questo contesto assume rilevanza l’Obiettivo 15 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, adottata nel 2015[32], che mira a proteggere, ripristinare e promuovere l’uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, con particolare attenzione alla gestione responsabile delle foreste, alla lotta contro la desertificazione e al contrasto della perdita di biodiversità[33].
Un primo vero strumento normativo sovranazionale volto a imporre agli Stati membri misure concrete per il ripristino degli ecosistemi degradati è, inoltre, il Regolamento UE 2024/1991, noto come Nature Restoration Law, entrato in vigore nel 2024[34]. Questo si inserisce nel quadro del Green Deal e della Strategia per la biodiversità 2030 e mira ad integrare la tutela ambientale in un approccio globale e intersezionale, sancendo l’obbligo di preservare e ripristinare gli habitat naturali essenziali, minacciati da fenomeni climatici e antropici.
Secondo il Regolamento, gli Stati membri devono adottare misure normative e amministrative per garantire il raggiungimento di obiettivi progressivi e misurabili nel tempo, con scadenze fissate al 2030, 2040 e 2050. In particolare, gli Stati sono tenuti alla consegna, entro due anni, di Piani Nazionali di Ripristino (PNR) all’Agenzia Europea dell’Ambiente e alla Commissione Europea che si occupano del monitoraggio del lavoro svolto e degli obiettivi raggiunti.
I Piani devono essere predisposti sulla base di pareri scientifici e della considerazione degli ecosistemi prioritari. Questi, inoltre, devono essere integrati con iniziative esistenti come la rete Natura 2000 e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e devono tener conto della natura self-executing del Regolamento UE 2024/1991, che impone la disapplicazione delle norme nazionali e regionali incompatibili[35] con esso.
Dunque, l’analisi complessiva evidenzia come il quadro normativo relativo al turismo sostenibile si fondi su un modello nel quale la protezione dell’ambiente e il benessere delle comunità locali rappresentano elementi imprescindibili per uno sviluppo economico equilibrato.
Numerose iniziative internazionali, unitamente alle politiche europee specifiche, hanno contribuito a definire principi guida e strumenti operativi capaci di integrare le esigenze economiche con quelle ambientali e sociali, favorendo un approccio multidimensionale e partecipativo.
Inoltre, la centralità delle aree protette, intese come laboratori per l’applicazione delle migliori pratiche, sottolinea l’importanza di una gestione responsabile delle risorse naturali, in grado di generare benefici diffusi e duraturi.
3. La governance del turismo sostenibile nelle leggi quadro sulle aree protette in Italia e Spagna
La governance del settore turistico, soprattutto quando le destinazioni sono rappresentante da aree protette, risulta fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell’ambito delle strategie e delle politiche adottate a livello internazionale ed europeo per lo sviluppo del turismo sostenibile. Unitamente, l’adozione di una legge quadro sulle aree protette riveste un ruolo essenziale in questo contesto, comprendendo la definizione di ruoli e responsabilità, nonché di strumenti di pianificazione e gestione delle risorse naturali presenti.
In Italia, il riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni relativamente al settore turistico ha comportato una gestione complessa e diversificata. Infatti, con la riforma del Titolo V della Costituzione, le Regioni hanno assunto competenza legislativa esclusiva nel settore e, di conseguenza, hanno avviato la produzione di una serie di normative diversificate tra di loro, sulla base delle specifiche esigenze territoriali[36], il che ha prodotto una frammentazione normativa.
Tuttavia, una soluzione a questa criticità è rappresentata dal Codice del Turismo, Decreto Legislativo n. 79/2011[37], il quale risponde a una duplice finalità. Da un lato quella di uniformare il quadro legislativo del settore turistico, rendendolo più coerente ed efficace[38], attraverso la codificazione e la sistematizzazione della normativa turistica nazionale, e dall’altro, quello di recepire la Direttiva 2008/122/CE.
Nonostante l’adozione di un Codice che unificasse la normativa nazionale del settore, l’azione legislativa delle singole Regioni continua a prevalere. Infatti, la stessa attuazione del Decreto Legislativo è stata ostacolata da processi di legittimità costituzionali, avviate contro alcune disposizioni proprio perché ritenute in contrasto con le competenze regionali[39].
Dal punto di vista amministrativo, la gestione del settore turistico è affidata al Ministero del Turismo e al Comitato Nazionale per il Turismo, istituito dall’art. 58 del Codice del Turismo, che svolgono un ruolo di coordinamento e supervisione delle politiche turistiche nazionali[40].
Il Comitato si occupa, inoltre, della promozione dell’immagine turistica dell’Italia all’estero, della gestione di progetti formativi e infrastrutturali di rilevanza turistica, nonché del supporto alle imprese turistiche, con l’obiettivo di migliorare la competitività del settore.
Un ulteriore attore fondamentale a livello centrale è l’Agenzia Nazionale del Turismo, nota con l’acronimo ENIT (Ente Nazionale Italiano per il Turismo), che ha il compito di promuovere l’Italia come destinazione turistica, sviluppando strategie di marketing, campagne promozionali e attività volte a incrementare la visibilità del Paese sui mercati esteri[41].
In Italia, la tutela dell’ambiente e i principi dello sviluppo sostenibile, rivestono un ruolo importante. Infatti, la riforma costituzionale avuta nel 2022, ha modificato gli articoli 9 e 41 della Costituzione italiana[42], proprio per consentire l’introduzione di questi valori all’interno della Carta costituzionale. In particolare, l’articolo 9, tradizionalmente dedicato alla promozione della cultura e della ricerca scientifica, è stato ampliato includendo esplicitamente anche la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, prevedendo la loro conservazione soprattutto nell’interesse delle future generazioni. Analogamente, l’articolo 41 sancisce che l’iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da compromettere la salute e l’ambiente, affermando così un principio di sostenibilità che deve orientare tutte le attività produttive, comprese quelle del settore turistico.
Questi principi si riversano, dunque, anche nel turismo, come confermato anche dalla giurisprudenza, che ha evidenziato l’importanza di garantire un equilibrio tra lo sviluppo turistico, la tutela ambientale e la conservazione del patrimonio culturale. In particolare, la sentenza n. 171/2012 della Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di disposizioni regionali che consentivano l’installazione di strutture ricettive prefabbricate all’interno di aree naturali protette, sottolineando la necessità di preservare il valore naturalistico di questi territori. Inoltre, le sentenze n. 121/2018 e n. 150/2019, hanno ribadito che l’interesse primario della tutela ambientale e culturale prevale in ogni caso sulla valorizzazione turistica. Quest’ultima deve, quindi, sempre tener conto di criteri di sostenibilità e dell’equilibrio del territorio.
In questo contesto si inserisce il Piano strategico del turismo 2023-2027, che pone la sostenibilità come uno dei suoi principi trasversali, integrandola in tutte le politiche e strategie per il futuro del settore.
Inoltre, in Italia, è stato istituito il Fondo per il turismo sostenibile[43], destinato a sostenere le iniziative che favoriscono un turismo responsabile, rispettoso dell’ambiente e del patrimonio culturale, e in grado di contribuire al benessere delle comunità locali.
La necessità di conciliare le esigenze proprie del turismo con la salvaguardia delle risorse naturali è conseguita anche attraverso una serie di norme che hanno portato all’istituzione delle aree naturali protette. Queste, in particolare, sono disciplinate dalla Legge quadro sulle aree protette (L. 394/1991), che definisce le tipologie di aree soggette a protezione e stabilisce i principi fondamentali per la loro gestione.
La normativa stabilisce una chiara distinzione tra le diverse tipologie di aree protette, individuando i parchi nazionali, i parchi naturali regionali e le riserve naturali (art. 2, L. n. 394/1991)[44].
L’istituzione delle aree protette avviene attraverso un processo articolato, regolato dal Programma Triennale per le Aree Naturali Protette (art. 4, L. n. 394/1991). Il processo prevede la circoscrizione territoriale dell’area protetta, la pianificazione dei fondi necessari alla gestione dell’area e il sostegno a iniziative per il recupero ambientale.
In materia di aree protette il legislatore è intervenuto, in particolare, su tre aspetti fondamentali. In primo luogo, attraverso una serie di limitazioni e divieti imposti all’interno di questi territori. Tali divieti riguardano sia le aree naturali, dove viene vietata l’attività di caccia o di cattura di specie protette e vengono limitate azioni che possono comportare il danneggiamento delle risorse naturali; sia nelle aree marine in cui vengono stabilite proibizioni riguardanti la pesca o attività che possono alterare le caratteristiche fisico-chimiche delle acque.
Un secondo ambito di intervento riguarda la fase della pianificazione per la gestione delle aree protette. In realtà, questo aspetto è attualmente in secondo piano, in quanto il Decreto Legge n. 112/1998 ha trasferito questo compito alle regioni e agli enti locali. In passato, invece, la legge prevedeva la creazione di un piano pluriennale economico e sociale, inerente le attività turistiche consentite all’interno delle aree e le loro modalità di svolgimento e promozione.
Infine, la regolamentazione dell’accesso alle aree protette rappresenta un ulteriore strumento per garantirne la sostenibilità. A tale scopo, vengono adottate misure per limitare l’afflusso turistico, evitando così il superamento della capacità di carico delle destinazioni.
L’insieme di queste misure si configura come un quadro normativo essenziale per assicurare che il turismo, all’interno di questi territori, avvenga in modo regolamentato e rispettoso dell’ambiente.
L’approccio integrato tra conservazione e fruizione sostenibile rappresenta, dunque, la chiave per garantire la salvaguardia e la valorizzazione delle aree protette nel lungo termine.
In Spagna, invece, la gestione del turismo è disciplinata da un quadro normativo che riflette il sistema decentralizzato del Paese.
L’articolo 148, comma 18, della Costituzione spagnola attribuisce la competenza in materia di turismo alle comunità autonome, concedendo loro la gestione esclusiva della promozione e dell’organizzazione turistica. L’articolo 149, d’altra parte, non stabilisce riserve di competenza statale, confermando che le comunità autonome hanno una notevole autonomia legislativa in questo ambito[45]. Di conseguenza, ogni comunità è in grado di adottare proprie leggi e misure in materia turistica, creando un quadro normativo variegato e diversificato in base alle specifiche esigenze locali.
A livello centrale, la gestione del settore turistico è affidata al Ministero dell’Industria, del Commercio e del Turismo e al Segretariato di Stato per il Turismo, responsabile della politica turistica nazionale[46]. Il Segretariato di Stato per il Turismo gestisce le relazioni istituzionali e si occupa del coordinamento di importanti enti operanti nel settore turistico: Turespaña, responsabile della promozione internazionale del turismo; i Paradores de Turismo, una rete di strutture alberghiere di lusso in edifici storici o di interesse culturale; e l’Organizzazione statale per l’innovazione e la gestione delle tecnologie del turismo (SEGITTUR), che si occupa della digitalizzazione e dell’innovazione del settore[47].
Inoltre, il settore turistico è monitorato e regolato da diversi organi amministrativi specializzati. Tra questi, la Conferencia Sectorial de Turismo e la Comisión Interministerial de Turismo sono due organismi chiave.
La Spagna ha visto un notevole sviluppo del settore turistico nel corso degli ultimi decenni, tuttavia, questa crescita ha comportato anche una serie di problematiche legate agli impatti ambientali e sociali del turismo di massa. Di conseguenza, si è diffuso un interesse collettivo volto ad ottenere un equilibrio tra la crescita economica del settore e la protezione dell’ambiente e delle comunità locali[48].
In risposta a ciò, il governo spagnolo ha implementato una serie di strategie finalizzate ad un miglioramento della qualità della vita, soprattutto di quelle popolazioni maggiormente colpite dal turismo di massa e di una serie di misure che garantissero la sostenibilità del settore.
Tra queste iniziative, il Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) rappresenta un pilastro fondamentale dell’impegno del Paese per un turismo responsabile, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030. Il PRTR comprende, infatti, una componente specifica, la Componente 14, dedicata alla promozione del turismo sostenibile[49]. Le azioni intraprese dal governo, attraverso il Piano, includono in particolare la regolamentazione del mercato degli alloggi turistici.
Inoltre, attraverso iniziative come la “Rete di Destinazioni Turistiche Intelligenti” e il piano “Ultimo Miglio”, si è incentivata la digitalizzazione del settore.
Parallelamente, sono stati avviati programmi per migliorare l’efficienza energetica, l’economia circolare e la riqualificazione del patrimonio storico.
In Spagna, dunque, il settore turistico è gestito prevalentemente attraverso piani dedicati a specifici ambiti. Oltre ai PRTR, infatti, anche i Planes de Sostenibilidad Turistica en destino, elaborati dal Ministero dell’Industria e del Turismo e della Segreteria di Stato del Turismo, sono volti a ottimizzare specifici aspetti del settore turistico. Questi riguardano la formazione degli operatori turistici su attività sostenibili o la risoluzione delle criticità legate al turismo di massa, attraverso la promozione di località meno conosciute e la distribuzione di flussi turistici in modo equo e rispettoso delle capacità di carico delle destinazioni.
In questo contesto, la Strategia per il Turismo Sostenibile 2030[50] rappresenta un quadro di riferimento per affrontare le sfide del settore. Il modello proposto dalla Strategia si basa su una crescita socioeconomica che favorisca la competitività e la redditività del settore, anche attraverso la digitalizzazione e che, allo stesso tempo, consenta la conservazione dei valori naturali e culturali delle destinazioni.
Per ottenere una maggiore efficienza nell’applicazione della Strategia e una maggiore aderenza alle necessità delle località in questione, un aspetto fondamentale è stata la partecipazione di amministrazioni pubbliche, di operatori del settore e delle comunità locali nei processi decisionali.
Dunque, come in Italia, anche in Spagna c’è un forte interesse nel favorire lo sviluppo di modelli di turismo che possano essere al contempo innovativi e competitivi ma anche ecologicamente sostenibili.
Anche in Spagna, inoltre, c’è un forte interesse nella valorizzazione e nella conservazione delle aree protette, soprattutto in relazione agli impatti del turismo. Nell’ordinamento spagnolo, svolge un ruolo cruciale in questo ambito la Legge sul Patrimonio Naturale e sulla Biodiversità (Legge n. 42/2007)[51].
Questa Legge prevede strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette per supportane la conservazione, con un’enfasi particolare sulla salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità e l’istituzione di fondi destinati al finanziamento di progetti di conservazione.
Questo approccio ha permesso di delineare, in maniera organica, diverse categorie di aree protette, tra cui Parchi Nazionali, Riserve Naturali, Aree Marine Protette, Monumenti Naturali e Paesaggi Protetti, ciascuna delle quali riveste un ruolo specifico nella tutela del patrimonio ambientale e culturale del Paese.
La normativa ha introdotto un modello organizzativo che, se, inizialmente, prevedeva una compartecipazione tra lo Stato e le Comunità Autonome[52], ha progressivamente orientato la gestione ordinaria verso queste ultime, affidando loro il compito di implementare e monitorare i Piani di gestione, in conformità alle direttive generali emanate a livello centrale[53].
Tale processo di decentralizzazione, pur evidenziando alcune criticità nella fase di transizione, ha contribuito a rendere la gestione delle aree protette più efficace e maggiormente adattabile alle specificità territoriali, favorendo l’autonomia operativa e la partecipazione della società civile[54], attraverso gli organismi di coordinamento e i Patronati[55].
Le Comunità Autonome, infatti, giocano un ruolo determinante nel sistema di gestione delle aree protette, potendo così sviluppare strumenti di pianificazione e azioni concrete che rispecchiano le peculiarità ambientali e culturali dei propri territori.
Questo modello di governance consente di implementare politiche più vicine alle esigenze locali e di promuovere un dialogo costante con la popolazione e le organizzazioni per la tutela del territorio.
Parallelamente, il Governo centrale mantiene una funzione coordinatrice e di supervisione fondamentale a garantire la coerenza e l’armonizzazione delle politiche di gestione su scala nazionale. Tra le sue attribuzioni rientrano la redazione del Piano generale di gestione della Rete dei Parchi Nazionali, il coordinamento della rete stessa e la definizione di direttive di base finalizzate a sopprimere usi incompatibili e a sostenere progetti di investimento.
La creazione di fondi dedicati e l’adozione di strumenti di pianificazione integrata, inoltre, consentono di coniugare l’interesse per lo sviluppo economico con quello per la tutela dell’ambiente, promuovendo un modello di gestione che mira a garantire un equilibrio tra utilizzo e conservazione, e a favorire la coesione territoriale attraverso la partecipazione attiva di tutti gli attori coinvolti.
4. Conclusioni
Per la valorizzazione del territorio naturale e per lo sviluppo sostenibile, appare fondamentale la connessione tra il settore turistico e l’istituzione di aree protette.
Il turismo, infatti, non solo rappresenta un mezzo di crescita economica, ma può divenire anche strumento di tutela e valorizzazione ambientale. Al contempo, le aree protette costituiscono il luogo ideale per favorire la protezione e la conservazione della biodiversità, ma rappresentano anche la spinta allo sviluppo di forme di turismo sostenibile.
Attraverso il confronto tra i due ordinamenti, quello italiano e quello spagnolo, appare evidente come in entrambi i casi ci sia la volontà dei governi di perseguire la crescita economica del settore turistico compatibilmente con il rispetto degli ecosistemi. Tuttavia, la gestione del settore turistico ed il perseguimento di questo obiettivo non è risultato sempre di semplice portata.
In entrambi i Paesi, infatti, sono emerse criticità in relazione al riparto di competenze nel settore, e di conseguenza, la necessità di un bilanciamento tra il ruolo dello Stato e quello delle Regioni o delle Comunità Autonome.
In Italia, pur essendoci una certa frammentazione normativa, dovuta alle competenze esclusive nel campo del turismo da parte delle Regioni, si è stabilita una governance centrale coordinata attraverso fonti di rango statale, quali il Codice del Turismo e la Legge quadro sulle aree protette.
In Spagna, invece, si sviluppa un modello più decentralizzato che tiene conto delle specificità territoriali e che si articola attraverso una serie di piani e strategie mirate su specifici ambiti del settore.
Tale modello, pur evidenziando una certa eterogeneità nella gestione, risulta efficace nel promuovere politiche di sostenibilità ambientale e, allo stesso tempo, attività innovative, grazie anche a strumenti come il Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
In entrambi i Paesi, nonostante i tentativi di creare un quadro normativo più omogeneo, la decentralizzazione e le differenti priorità locali mantengono un certo grado di frammentazione nella gestione del settore.
Dunque, una gestione del settore turistico che consenta di ottenere al contempo una crescita equilibrata e un bilanciamento tra fruizione turistica e conservazione ambientale, è possibile attraverso una buona comunicazione tra i vari livelli di governo, il coinvolgimento attivo degli attori locali, la sensibilizzazione dei visitatori e l’adozione di pratiche di turismo ecocompatibile.
Questi, infatti, rappresentano strumenti fondamentali per la conservazione degli ecosistemi e per garantire un’esperienza turistica autentica e consapevole, capace di generare benefici diffusi per l’intera collettività.
[1] C. Donato, Per un turismo sostenibile, in C. Donato (a cura di), Turismo rurale, agriturismo ed ecoturismo quali esperienze di un percorso sostenibile, Trieste, Edizioni Università di Trieste, 2007, 13 ss.
[2] A. Montanari, Turismo urbano. Tra identità locale e cultura globale, Milano, Mondadori, 2008, 2ss.
[3] F. Lara de Vicente, T. J. López-Guzmán Guzmán, Turismo sostenible: un enfoque multidisciplinar e internacional, Córdoba, UCOpress Editorial Universidad de Córdoba, 2005, 1ss.
[4] P.M. Vipiana, Diritto pubblico del turismo, Pisa, Pacini Editore, 2020, 13ss.
[5] Un accademico e avventuriero, affiliato al Forum International di Berkeley, in California, accreditato, secondo il Contra Costa Times, come colui che ha coniato il termine “ecoturismo” nel 1965.
[6] G. Cassano (a cura di), Diritto del Turismo, Rimini, Maggioli Editore, 2019, 82.
[7] Per informazioni sull’Organizzazione, si rimanda a www.unwto.org.
[8] Un esempio emblematico di tale orientamento è rappresentato dai provvedimenti adottati da alcune amministrazioni locali, volti a limitare o regolare l’afflusso di visitatori. Tra questi, spicca il caso della città di Venezia, che ha recentemente introdotto un ticket d’ingresso per tutti i visitatori. Tale misura è disciplinata dal Regolamento per l’istituzione e la disciplina del Contributo di accesso, con qualsiasi vettore, alla città antica del comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna, approvato nella seduta del 26 febbraio 2019. L’introduzione di questo contributo è stata resa possibile dall’autorizzazione concessa a livello statale attraverso la legge di bilancio 2019.
[9] R. Santagata, Diritto del turismo, Milano, Utet Giuridica, IV, 2018, 103 ss.
[10] R. Knafou, S. Pickel, Tourisme et “développement durable”: de la lente émergence à une mise en œuvre problématique, in Géoconfluences, 2011, 8.
[11] F. Morandi, F. Niccolini, D. Marzo, M. Sargolini, A. Tola, A. Usai (a cura di), Organizzazione e pianificazione delle attività ecoturistiche: principi ed esperienze, Milano, Franco Angeli, 2013.
[12] Il turismo naturalistico si concentra sulla scoperta e sull’esplorazione degli ecosistemi, ponendo l’accento sulla valorizzazione della biodiversità e sul contatto diretto con la natura.
[13] Il turismo d’avventura, invece, è caratterizzato da esperienze dinamiche e adrenaliniche, che includono attività all’aria aperta come trekking, rafting, arrampicata e altre pratiche sportive in contesti naturali.
[14] M.G. Pulvirenti, Riflessioni sull’accessibilità delle aree naturali protette e dei beni culturali, in AmbienteDiritto, 2024, 2, 1.
[15] G. Componente, Le aree protette, in A. Catelani, S. Cattaneo (a cura di), Trattato di Diritto Amministrativo. I beni e le attività culturali, Padova, Cedam, 2002, 509 ss.
[16] Un momento fondamentale nella storia delle aree naturali protette è rappresentato dal 1962, anno del primo Congresso mondiale dei parchi, cui parteciparono anche le Nazioni Unite, a dimostrazione della crescente rilevanza della tematica.
[17] F. Morandi, F. Niccolini, D. Marzo, M. Sargolini, A. Tola, A. Usai (a cura di), Organizzazione e pianificazione delle attività ecoturistiche: principi ed esperienze, Milano, Franco Angeli, 2013
[18] C. Criscione, B.N. Romano, Diritto del turismo. L’evoluzione dal consumatore al viaggiatore, Torino, Giappichelli, 2019, 1 ss.
[19] Per approfondimenti sullo sviluppo sostenibile si rimanda a V. Pepe, Fare Ambiente. Teorie e modelli giuridici di sviluppo sostenibile, Milano, Franco Angeli, 2008.
[20] F. Fracchia, S. Vernile, Lo sviluppo sostenibile oltre il diritto ambientale, in Le Regioni, 2022, 1-2, 15 ss.
[21] N. Carnimeo, L. Marchetta, Attività turistiche e aree marine protette: compatibilità e principi di gestione efficace, in AmbienteDiritto, 2023, 2, 7.
[22] M. del C. Cañizares Ruíz, Sostenibilidad y turismo: de la documentaciòn internacional a la planificaciòn en espana «Horizonte 2020», in Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 2013, 61, 76.
[23] Per approfondimenti si rimanda a www.european-union.europa.eu.
[24] La Dichiarazione di Glasgow promuove, inoltre, una trasformazione giusta e inclusiva, con particolare attenzione ai gruppi sottorappresentati e vulnerabili, tra cui donne, comunità indigene, persone con disabilità e stati insulari di piccole dimensioni.
[25] Tutti gli attori del settore turistico possono aderire all’iniziativa diventando firmatari, contribuendo così ad accelerare l’azione per il clima. L’adesione comporta l’impegno a rispettare gli obiettivi definiti nella Dichiarazione. L’iniziativa offre supporto ai firmatari, fornendo loro conoscenze, risorse e strumenti necessari per conseguire gli obiettivi prefissati. Inoltre, promuove azioni per lo sviluppo e l’implementazione di piani d’azione climatica, favorendo il monitoraggio e la rendicontazione dei progressi.
[26] Si tratta di un programma pluriennale comunitario presentato dalla Commissione europea per i trasporti e il turismo al Consiglio dell’Unione Europea, destinato a coprire il periodo dal 1997 al 2000, non risulta più operativo. L’ultima interrogazione scritta riguardante tale programma è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, serie C, n. C 093 E del 2002, nella quale venivano evidenziati i significativi cali nel settore turistico a seguito degli attentati dell’11 settembre 2001.
[27] Per ulteriori approfondimenti si rimanda a www.eur-lex.europa.eu.
[28] Per approfondimenti si rimanda a www.affarieuropei.gov.it.
[29] E. Rodary, Créer du lien social par le tourisme, une utopie soutenable?, in G. Froger, Tourisme durable dans les Suds?, Bruxelles, Peter Lang, 2010, 37 ss.
[30] Le forme di turismo legate alle aree protette si sono dimostrate particolarmente durature nel tempo, risalendo in alcuni paesi del Sud globale alla prima metà del XX secolo. Ad esempio, già negli anni Trenta i parchi nazionali africani costituivano un’industria emergente. A partire dagli anni Cinquanta, con la progressiva internazionalizzazione delle politiche di conservazione della natura, l’argomento economico a sostegno delle aree protette si è consolidato, rafforzando il ruolo dei parchi e delle riserve nello sviluppo turistico. Ancora oggi, i ricavi generati da queste aree rappresentano un elemento fondamentale per garantirne la sostenibilità.
[31] Per approfondimenti si rimanda a www.unesco.it.
[32] Recenti studi dell’Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO) sottolineano come il turismo possa contribuire, direttamente e indirettamente, al raggiungimento di tutti i 17 obiettivi dell’Agenda 2030, se gestito in modo sostenibile e praticato in modo responsabile. Si rimanda a L. Colella, Dal Terzo Settore all’“économie sociale et solidaire” in Francia. Il “turismo sociale e solidale”: un modello di sviluppo equo e sostenibile, in Società E Diritti, 8, 15, 2023, 158.
[33] In particolare, l’Obiettivo 15 prevede azioni concrete volte a fermare la deforestazione e incentivare il rimboschimento, a garantire la conservazione delle aree montuose e delle zone umide e a combattere il degrado del suolo, con l’obiettivo di ripristinare le terre colpite da desertificazione, siccità e inondazioni entro il 2030. Un altro aspetto cruciale riguarda la protezione della fauna e della flora minacciate, attraverso misure urgenti per contrastare il bracconaggio e il commercio illegale di specie protette. Inoltre, questo obiettivo evidenzia quanto sia essenziale integrare la biodiversità e la tutela degli ecosistemi nelle politiche di sviluppo nazionali e locali, promuovendo una gestione equa e sostenibile delle risorse genetiche.
[34] L’iter di approvazione del regolamento ha evidenziato forti divisioni politiche tra gli Stati membri, con il voto contrario di Italia, Ungheria, Polonia, Paesi Bassi, Finlandia e Svezia, mentre il Belgio si è astenuto. L’opposizione, prevalentemente di orientamento conservatore, riflette timori legati agli impatti del regolamento sulla sicurezza alimentare e sulla sovranità economica. A fronte di queste resistenze, il Parlamento europeo ha introdotto una clausola di “freno di emergenza” che consente la sospensione temporanea delle disposizioni regolamentari in caso di gravi conseguenze per la sicurezza alimentare.
[35] M. Ferrara, A prima lettura del regolamento UE sul ripristino della natura (reg. UE 2024/1991), in Federalismi, 2024, 24, 125.
[36] V. Franceschelli, F. Morandi, Introduction to italian tourism law, in C. Torres, F.J. Melgosa Arcos, V. Franceschelli, F. Morandi (a cura di), Tourism Law in Europe, Estoril, Eshte, 2022, 305.
[37] Per approfondimenti si rimanda a G. Cardosi, E.M. Tripodi, Il codice del turismo, Rimini, Maggioli Editore, 2011.
[38] Anche la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto l’esigenza di un intervento normativo statale più incisivo nel settore turistico. Con la sentenza n. 76/2009, ad esempio, la Corte ha ribadito la necessità di un intervento del legislatore statale in materia turistica, pur riconoscendo che essa rientra tra le competenze residuali delle Regioni. Tuttavia, ha ammesso la possibilità di una regolamentazione statale subordinandola a due condizioni fondamentali: la presenza di un interesse unitario e il rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.
[39] Corte costituzionale, sentenza n. 80/2012.
[40] V. Sale, Il ritorno del Ministero del turismo: il nuovo capitolo di una saga decennale, in Rivista italiana di diritto del turismo, 35, 1, 2022, 27 ss.
[41] L. Righi, L’istituzione del Comitato Nazionale del Turismo e la trasformazione dell’E.N.I.T. in agenzia: segni di rinascita dell’organizzazione pubblica centrale del turismo?, in Diritto del turismo, 1, 2006, 5ss.
[42] Per approfondimenti si rimanda a D. Amirante, Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l’Antropocene, Bologna, Il Mulino, 2022; V. Pepe, Le “nuove frontiere” del costituzionalismo ambientale: prospettive emergenti nel diritto comparato, in DPCE, 2023, 2.
[43] Il Fondo istituito dall’articolo 1, comma 611, della legge n. 197/2022, e disciplinato dal Decreto Ministeriale del 22 marzo 2023, è destinato alla promozione dell’ecoturismo e del turismo sostenibile. Con una dotazione complessiva di 25 milioni di euro, il Fondo ha una durata triennale (2023-2025) e si rivolge in particolare alle strutture ricettive e alle imprese turistiche. Gli interventi previsti sono finalizzati a potenziare le principali destinazioni culturali, incentivando forme di turismo sostenibile, contrastando il sovraffollamento turistico, sviluppando itinerari innovativi e favorendo la destagionalizzazione del turismo. Inoltre, il Fondo promuove la transizione ecologica nel settore turistico, incoraggiando il turismo intermodale e la riduzione delle emissioni, e supporta le strutture ricettive e le imprese turistiche nel conseguire certificazioni di sostenibilità.
[44] I parchi nazionali sono territori terrestri, fluviali, lacustri o marini caratterizzati dalla presenza di ecosistemi intatti o parzialmente alterati dall’intervento umano. Per la loro rilevanza scientifica, naturalistica, estetica e culturale, necessitano di un intervento statale per garantirne la conservazione, a beneficio delle generazioni presenti e future. La gestione di tali parchi è affidata allo Stato, che ne cura l’amministrazione e la tutela attraverso enti appositi. I parchi naturali regionali, invece, comprendono aree di valore naturalistico e ambientale che riguardano una o più regioni limitrofe. La loro istituzione mira a preservare assetti naturali, paesaggistici, artistici e tradizioni culturali locali, con una gestione affidata alle amministrazioni regionali. Le riserve naturali sono aree destinate alla protezione specifica di specie della flora e fauna di particolare interesse scientifico e conservazionistico. Tali riserve possono essere statali o regionali, a seconda della rilevanza degli interessi rappresentati. Infine, in merito all’ambiente marino, la normativa distingue tra le aree protette istituite secondo il Protocollo di Ginevra per la protezione del Mediterraneo e quelle definite dalla Legge n. 979/1982.
[45] Anche la giurisprudenza costituzionale, con la sentenza n. 200/2009, ha ribadito la ripartizione delle competenze tra Stato e Comunità Autonome in materia di turismo, riconoscendo a queste ultime un ruolo predominante nella gestione e promozione del settore. Sebbene lo Stato possa intervenire per ragioni di coordinamento economico e legislazione di base, non può imporre una regolamentazione dettagliata né una gestione centralizzata che limiti l’autonomia regionale. Il Tribunal Constitucional ha sottolineato che il turismo, essendo strettamente legato alle specificità territoriali, rientra nelle competenze autonome e che l’intervento statale deve limitarsi alla definizione di principi generali senza compromettere la capacità delle Comunità Autonome di sviluppare politiche proprie. Questo principio, consolidato anche in precedenti sentenze come la STC n. 13/1992 e la STC n. 242/1999, garantisce un equilibrio tra il coordinamento nazionale e la discrezionalità regionale nella gestione delle strategie turistiche.
[46] R. Pèrez Guerra, Introducción. La política turística europea y la administración turística del Estado, in S. Fernàndez Ramos, Manual de Derecho Administrativo del sector turístico, Madrid, Tecnos, 2013, 23.
[47] M. Capelli, E. Grasso, Il turismo fra persona e mercato: alcune riflessioni di diritto comparato, in DPCE, 2, 2020, 1109.
[48] D. Moreno Duque, Turismo de naturaleza en España. Nuevas realidades, nuevos modelos de turismo sostenible, in Observatorio Medioambiental, 2022, 25, 199 ss.
[49] Per approfondimenti si rimanda a www.mintur.gob.es.
[50] Per approfondimenti si rimanda www.turismo.gob.es.
[51] La Legge n. 33/2015 ha introdotto una serie di modifiche alla Legge n. 42/2007. Tra le principali modifiche, si evidenziano l’aggiornamento delle competenze nella gestione delle risorse marine, l’inclusione di informazioni relative agli spazi protetti nei registri immobiliari, e il sostegno alle attività nella Rete Natura 2000 che contribuiscono al benessere delle comunità locali e alla creazione di occupazione. Inoltre, sono state regolamentate iniziative per la reintroduzione di specie autoctone estinte e l’accesso e l’uso delle risorse genetiche delle specie selvatiche, nel rispetto degli accordi internazionali, come il Protocollo di Nagoya, per un utilizzo sostenibile delle risorse naturali.
[52] M. Alberton, Le dinamiche interistituzionali nell’ordinamento spagnolo tra decentramento, accentramento e “balzi asimmetrici”: il caso della tutela dell’ambiente, in DPCE, 2020, 3, 3061 ss.
[53] La giurisprudenza costituzionale ha consolidato un principio di equilibrio nel riparto delle competenze tra lo Stato e le Comunità Autonome in materia ambientale, riconoscendo la necessità di un coordinamento statale nei casi in cui un fenomeno abbia una dimensione sovraterritoriale, senza tuttavia svuotare le attribuzioni regionali. La sentenza n. 53/2016 del Tribunal Constitucional ribadisce che, sebbene la protezione dell’ambiente rientri tra le competenze delle Comunità Autonome, lo Stato può assumere funzioni esecutive e di coordinamento quando l’impatto di un determinato fenomeno superi i confini regionali, garantendo così un’azione uniforme ed efficace. Tale coordinamento non si traduce in un’ingerenza nelle prerogative autonome, ma piuttosto nella creazione di un quadro che favorisca la collaborazione interistituzionale, nel rispetto delle competenze di ciascun livello di governo. Per approfondimenti sul tema delle competenze in materia ambientale si rimanda a C. Petteruti, Diritto dell’ambiente e dell’energia. Profili di comparazione, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2020.
[54] R. Tutinelli (a cura di), La disciplina delle aree protette: Francia, Germania, Regno Unito e Spagna, Senato della Repubblica, 2013, 25.
[55] Ogni Parco nazionale è supportato da un Patronato, composto da rappresentanti delle amministrazioni e di enti collegati al Parco. Il Patronato vigila sull’applicazione delle normative, promuove la gestione, approva il Piano di gestione e la memoria annuale, e propone progetti e regolamenti per la tutela del Parco.