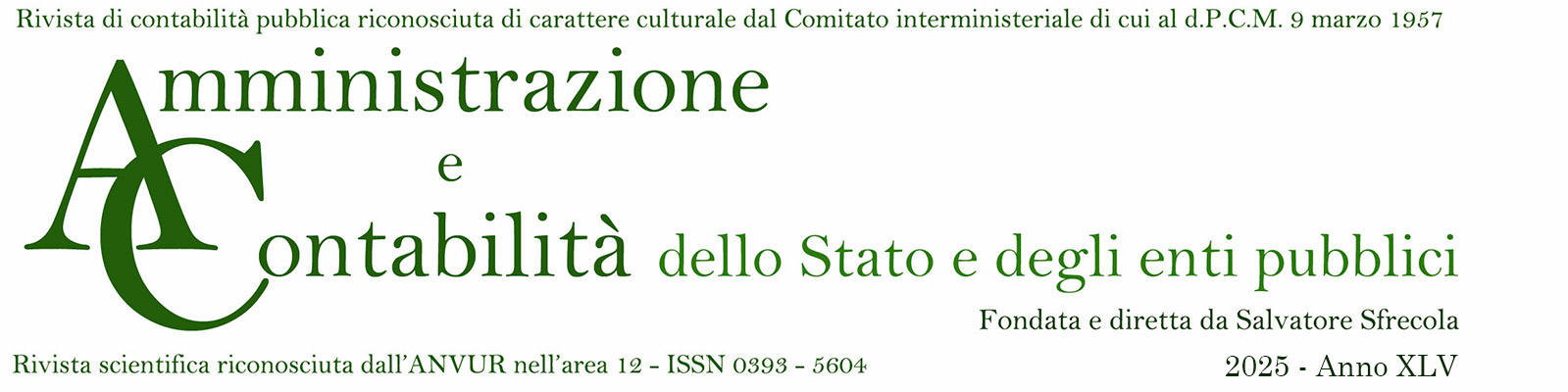di Pelino Santoro – Presidente on. della Corte dei conti
Sono grato al procuratore Leoni che con le sue pertinenti e calibrate considerazioni mi fornisce l’occasione di chiarire la mia posizione che non vuole essere disfattista di un ordine esistente, ma solo un invito alla prudenza nell’adattare al nuovo “regionalismo contabile” un istituto secolare che l’attivismo di un Collegio speciale, va modellando, con un percorso non sempre coerente e spesso condizionato da un azzardato e tignoso protagonismo dei procuratori regionali[1].
La mia segnalazione si è limitata a registrare una significativa divergenza di impostazione tra la ricorrente procura “territoriale” e la procura generale (interveniente necessaria), supportata dal dichiarato disconoscimento della legittimazione al ricorso della prima.
Nella precedente nota alla pronuncia di massima delle Sezioni Riunite n. 34/2024[2], pur prendendo atto delle “due verità” acclarate, una di diritto vivente (la natura non processuale del giudizio di parifica) e l’altra di diritto vigente (l’impugnabilità della delibera di parifica), avevo espresso qualche riserva sulla non chiara coerenza della seconda verità, per aver trascurato di prendere nella dovuta considerazione la riconosciuta “atipicità” della di parificazione che si esteriorizza con una deliberazione/decisione (non sentenza) adottata con le formalità contenziose e quindi con il mero intervento del Procuratore contabile.
Nel successivo commento alla deliberazione delle Sezioni Riunite spec., 17 febbraio 2025, n. 3, mi sono limitato a trarre, con non malcelata soddisfazione, la conclusione che, al di là del rigorismo di bandiera e del palese conflitto tutto interno all’ufficio del pubblico ministero contabile, la vicenda consolida la convinzione dell’assurdità giuridica di un ricorso oppositivo di un organo interveniente, in funzione collaborativa, nello svolgimento di un procedimento ausiliare all’assemblea legislativa, tanto più che il conseguente ritardo altera il “ciclo di bilancio”,[3] con evidenti ripercussioni sulla certezza dei conti pubblici, perché genera confusione contabile in considerazione del fatto che l’eventuale ricalcolo del “nuovo” risultato di amministrazione si riverbera a cascata, per effetto del principio di continuità, sugli esercizi successivi, sconvolgendone gli equilibri[4].
Nel noto dibattito in atto, che richiederebbe secondo alcuni un chiarimento normativo, mi sembra riduttivo invocare, come se fosse vangelo, una datata pronuncia delle S.R. in speciale composizione (n. 7/2020) che ricorda, come punto fermo sui cui vi è consenso unanime, che “oggetto del giudizio di parificazione è la legalità del rendiconto generale dell’esercizio e, quindi, del correlato risultato di amministrazione”, con “funzione «accertativa», di riscontro della conformità – in termini di regolarità–legittimità – dei «fatti» contabili rappresentati nel rendiconto rispetto ai parametri costituzionali e alle norme dell’ordinamento giuridico-contabile vigenti nell’esercizio analizzati; la differenza, tuttavia, sta in proprio in quella indicata come enfasi aggiunta che l’accertamento effettuato «fa stato» nei confronti delle parti, una volta decorsi i termini di impugnazione” , dal momento che manca un norma vigente e quindi l’impugnazione della parifica è mero frutto di una interpretazione assunta come mero “diritto vivente“ , che, in quanto tale può mutare nel tempo[5], a prescindere da eventuali interventi normatici, come auspicato dalla stessa Corte costituzionale[6].
Per il momento il tema da definire è semplicemente quello del ruolo del procuratore regionale indicato (nella delibera commentata) nel potere di agire in giudizio per la tutela degli interessi dell’intera collettività alla corretta gestione[7], ma allo steso tempo si emargina la posizione del procuratore Generale (interventore necessario senza poteri !); la qui la mirata provocazione del segnalare una “spaccatura”, tale da far ritenere in non cale la motivata rinuncia al ricorso azionato dal procuratore in assenza di autonoma legittimazione, ma idonea alla perpetuatio iudicii, sebbene con la spendita di una moneta non spendibile.
Da sempre la parificazione è ritenuta un passaggio essenziale che legittima l’attività svolta nell’anno di riferimento conferendo certezza ai risultati della gestione, producendone la irrevocabilità[8], dal momento che il rendiconto generale una volta approvato non può essere modificato in nessuna delle sue parti (art. 150 R.c.s.) ed in ciò consiste la sua rilevanza giuridica[9].
La parificazione rappresenta la massima espressione della funzione ausiliaria nei confronti del Parlamento della magistratura nella sua posizione di indipendenza e di terzietà e il relativo giudizio, propedeutico alla presentazione in Parlamento del progetto di legge per l’approvazione del rendiconto, conferisce giuridica certezza alle risultanze dei conti pubblici, quale momento culminante a chiusura del ciclo annuale dei controlli demandati alla Corte dei conti[10].
La certezza e la veridicità dei risultati finanziari verificati[11], è conseguenza della indipendenza che il carattere magistratuale assicura[12] e dalla indipendenza e neutralità della funzione svolta; l’indipendenza della magistratura presuppone in particolare che l’organo giurisdizionale interessato possa svolgere le sue funzioni giurisdizionali in piena autonomia, senza vincoli gerarchici o di subordinazione nei confronti di alcun altro organo e senza ricevere ordini o istruzioni da alcuna fonte, restando al riparo da interventi o pressioni dall’esterno tali da compromettere l’indipendenza di giudizio dei suoi membri e da influenzare le loro decisioni[13].
L’effetto dell’accertamento giurisdizionale consiste nel conferimento di certezza giuridica al risultato di amministrazione si proietta sugli esercizi successivi, e in particolare su quello in corso tramite il risultato di amministrazione presunto[14]; oggetto del giudizio di parificazione, pertanto, è la “validazione” del risultato di amministrazione ed i relativi effetti si ripercuotono sull’equilibrio giuridico e concreto del ciclo bilancio[15], conferendo “certezza giuridica” ai risultati del rendiconto al fine di consentire al ciclo riconciliato di bilancio di proseguire nel corso del tempo su basi solide e certificate[16] e alla verifica di legalità.
La parificazione, tuttavia, conferisce certezza solo al rendiconto parificato, relativo allo specifico esercizio finanziario, i cui risultati non sono modificabili[17].
Il richiamo, anche per la parificazione dei rendiconti regionali, alle “formalità della giurisdizione contenziosa” non fa che confermare, da un lato, la sostanziale natura di controllo della relativa attività e, dall’altro, la volontà di rendere intangibili, con l’efficacia del giudicato, le risultanze del rendiconto generale, sottoposte all’approvazione del consiglio regionale[18].
La parifica, quindi, esplica una funzione di “garanzia rafforzata” sugli equilibri di bilancio presenti e futuri, dal momento che ogni determinazione infedele del risultato di amministrazione e delle risultanze economiche e patrimoniali “si riverbera a cascata sugli esercizi successivi” con l’effetto di pregiudicare nel tempo gli equilibri e le operazioni di risanamento[19]; il riassorbimento del disavanzo in periodi che vanno ben oltre il ciclo di bilancio ordinario comporterebbe una lesione a tempo indeterminato dei precetti costituzionali evocati che finisce per disincentivare il buon andamento dei servizi e scoraggiare le buone pratiche ispirate a una oculata e proficua spendita delle risorse della collettività[20],
L’istituto della parificazione dei rendiconti annuali regionali, ha acquistato un decisivo e rinnovato ruolo, poichè assicura non solo la verifica delle riscossioni e dei pagamenti e dei relativi resti (residui) ma anche, e soprattutto, la verifica, a consuntivo, degli equilibri sulla base del bilancio preventivo e di tutte le disposizioni sopravvenute che ne hanno modificato la struttura, sintetizzati dal risultato di amministrazione, la cui esatta determinazione costituisce, pertanto, l’oggetto principale del procedimento, in linea con la funzione strumentale al ruolo di garante imparziale dell’equilibrio economico finanziario del settore pubblico rimesso alla Corte dei conti con il giudizio di parificazione[21].
La “parificazione” in senso stretto, infatti, consiste in un’operazione matematica, e formale, diretta a costatare l’equivalenza globale fra poste attive e passive di ciascun prospetto del “rendiconto generale” al fine di emettere la dichiarazione sulla correttezza dei saldi, in termini di pareggio, avanzo o disavanzo[22].
Nel giudizio di parifica, pertanto, diventa centrale la correttezza della determinazione dell’accertamento del risultato di amministrazione, il quale costituisce “l’oggetto principale e lo scopo del giudizio di parificazione che riguarda non solo la verifica delle riscossioni e dei pagamenti e dei relativi resti (residui) ma anche, e soprattutto, la verifica, a consuntivo, degli equilibri di bilancio” (C. cost., n. 89/2017).
In definitiva, il giudizio di parificazione ha a oggetto la rendicontazione e i risultati della gestione, che devono essere, oltre che certi, in fatto, “validi” in diritto; l’effetto giuridico della parificazione è la certezza del diritto e la stabilità dell’accertato, come già evidenziato dalla Corte costituzionale sin dalle sue prime pronunce e, perciò, costituisce un importante ed indispensabile tassello per assicurare “il preminente interesse pubblico della certezza del diritto”, insieme con l’altro dell’osservanza della Costituzione[23], conferendo alle risultanze accertate il crisma della incontestabilità, con il valore processuale del “giudicato, ovvero quello della definitività ed insindacabilità (C. cost. n. 121/1966).
A questa fondamentale funzione “certativa” del giudizio di parificazione si associa, quale suo logico sviluppo, l’altrettanta fondamentale funzione “prescrittiva” del giudizio stesso; il giudizio di parificazione, infatti, nel certificare i saldi della gestione, per ciò stesso crea un vincolo di conformazione ad essi delle successive leggi di bilancio, partecipando in tal modo all’iter di formazione della legislazione regionale; in conseguenza, finché non sia intervenuta l’approvazione del rendiconto di un determinato esercizio e il recupero del relativo disavanzo presunto, è necessario iscrivere l’intero importo del disavanzo non ripianato nel bilancio dell’esercizio in corso di gestione (C. cost. n. 246/2021).
Rendicontazione e programmazione, infatti, sono legate, nella loro dimensione teleologica, dalla necessaria parametrazione delle spese di bilancio autorizzabili alle risorse disponibili, nella continuità dell’azione amministrativa e dei relativi cicli di bilancio.
Per il momento si è esclusa l’impugnabilità della (sola) relazione allegata al giudizio di parifica, trattandosi di atto funzionalmente distinto, che concerne la complessa attività svolta e non soltanto i dati di rendiconto, sino ad allargare il proprio orizzonte a profili di tipo gestionale[24].
Nel caso di Genova il Procuratore regionale eccepisce l’inammissibilità (improcedibilità) del ricorso della Procure a regionale per la patente violazione del principio dell’unicità dell’Ufficio del Pubblico Ministero, poiché avrebbe dovuto trasmettere il ricorso alla Procura Generale per il suo deposito. Nella fattispecie, invece, si è realizzata la paradossale situazione per la quale la Procura Generale, chiamata in giudizio quale controparte, dovrebbe condividere e sostenere un ricorso presentato e depositato autonomamente da un Procuratore regionale come fosse una qualsiasi parte privata estranea all’ufficio del PM; Il ricorso, inoltre, il ricorso d sarebbe inammissibile soprattutto per l’altra ragione che la parificazione del rendiconto generale (che sia dello Stato o della Regione) è un procedimento riferibile esclusivamente alla funzione del controllo che nulla ha a che vedere con l’attività giurisdizionale e che trova i riferimenti normativi nel parametro dell’art. 100, secondo comma, della Costituzione e negli articoli 39, 40 e 41 del r.d. 1214 del 1934.
Nel procedimento di controllo che si conclude con la parifica, nei casi in cui il procuratore generale (ovvero regionale) viene chiamato a partecipare alle camere di consiglio delle sezioni riunite in l’unico scopo di questa partecipazione è quello di informare il procuratore stesso dei temi principali oggetto della parifica, al fine di consentirgli una migliore formulazione della requisitoria nel corso della udienza di parifica.
Egli partecipa per realizzare le formalità contenziose che la legge richiede, ma non è parte del procedimento di controllo e, se pur si voglia considerarlo parte interveniente necessaria nell’udienza di parifica, certamente non ha nessun potere di reazione alla decisione di parifica non essendo appunto stato parte del procedimento e neppure un contraddittore nel senso pieno della parola; l’unico scopo di questa partecipazione è quello di informare il procuratore stesso dei temi principali oggetto della parifica, al fine di consentirgli una migliore formulazione della requisitoria nel corso della udienza di parifica; il procuratore regionale, quindi, partecipa per realizzare le formalità contenziose che la legge richiede ma non è parte del procedimento di controllo e, se pur si voglia considerarlo parte interveniente necessaria nell’udienza di parifica, certamente non ha nessun potere di reazione alla decisione di parifica non essendo appunto stato parte del procedimento e neppure un contraddittore nel senso pieno della parola.
La posizione coraggiosa assunta dalla Procura generale, in aderenza al dictum della questione di massina di cui alla pronuncia S.R n. 34/2024, cit. implicando la carenza del potere di impugnativa del Procuratore regionale, potrebbe ricondurre a sistema il giudizio di parificazione regionale, che, sebbene regolato dall’unica fonte di rinvio dinamico (art. 42, T.U. n. 1214/1934) soffre di una marcata asimmetria rispetto alla medesima funzione svolta nei confronti del Rendiconto generale dello Stato, ed è percepita come un ritorno al riaccentramento della funzione in termini di contendibilità e definitività dell’esito accertativo[25].
La posizione della Procura generale si completa con l’osservazione che “a veder bene, la ricostruzione, che esclude la possibilità per il PM di impugnare la decisione di parifica è chiaramente accolta dal codice di giustizia contabile che, agli articoli 123 e seguenti, nel disciplinare il giudizio dinanzi alle sezioni riunite in speciale composizione non contempla, in nessuna disposizione, il Procuratore generale (o regionale) quale ricorrente; d’altra parte è noto che il pubblico ministero in sede di parifica è stato sempre visto come organo di garanzia e non come parte[26].
La tesi della Procura regionale, ove condivisa, comporterà un cambio di rotta del “diritto vivente, ovvero il suo abbandono, con riconduzione a sistema della parificazione regionale, superando ogni asimmetria e qualsiasi sospetto centralistico della funzione che rimarrà incardinata nel territorio, con implicito abbandono dell’esercizio della funzione quale “potere” per conto dello Stato; l’approdo ermeneutico della Procura generale si basa sulla considerazione che Il ruolo di garanzia del procuratore contabile, che non è parte in senso sostanziale è, infatti, coerente con l’assenza di poteri propulsivi in fase istruttoria, in quanto “gli elementi e le informazioni utili alla decisione di parifica devono essere acquisiti direttamente dalle Sezioni di controllo, che restano le destinatarie del flusso documentale acquisito in fase istruttoria e che costituiscono l’interlocutore naturale delle Amministrazioni regionali[27].
Tutto ciò chiarito, ringrazio il collega e il Direttore della rivista che ci ospita, per avermi consentito di sviluppare una segnalazione che voleva essere solo un flash provocatorio di un possibile confronto “de iure condendo”.
Ma la questione non è chiusa perché pone in primo piano il problema della impugnabilità di un atto rientrante nell’esercizio di una funzione, nata come ausiliare al potere delle assemblee legislative, non avendo alcun senso riconoscere tale ultronea facoltà/diritto ad un organo assembleare (Consiglio regionale) che ha già l’ultima parola in sede di approvazione legislativa del rendiconto presentato dalla giunta.
Resta inteso che in caso di opposizione/ricorso della Regione la Procura generale resta intervenente necessaria nel giudizio oppositivo innanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione fino a quando il diritto vivente lo consentirà.
Quanto all’abusato refrain della tutela degli interessi adespoti, mi permetto di segnalare che, nella genuina lettura della Corte costituzionale, è la Corte dei conti nel suo insieme che, ai fini della sua legittimazione come giudice a quo, è vista come centro d’imputazione di interessi adespoti di natura finanziaria, insuscettibili di puntualizzarsi in posizioni soggettive tutelabili in sede giurisdizionale e per questo a rischio di finire in “zone d’ombra” o “zone franche”[28].
Tornando alla legittimazione del procuratore regionale, va tento presente che una volta (ri)qualificato il giudizio di parifica come procedimento e non più come processo (S.R. b. 34/2024/QM) rimarrebbe una vera anomali di sistema continuare (unico caso) a riconoscere la sua legittimazione ad impugnare direttamente, in posizione attizia, un procedimento di controllo, mentre in tutti gli altri giudizi su ricorso innanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione (art. 6 c.g.c.) solo al procuratore generale è riconosciuta la posizione di parte necessaria interveniente (art., 127, comma 2, c.g.c.), nel giudizio eventualmente attivato dall’amministrazione regionale.
[1] Emblematico resta il caso Sicilia, che ha dato luogo ad auna questione di costituzionalità ed a un conflitto di attribuzione per risolvere una controversia, innescata da un ricorso del Procuratore di mera correzione dell’atto decisorio carente delle intestazione di “sentenza”.
[2] P. Santoro, Il giudizio di parificazione allo specchio. Le due verità, in Riv. C. conti 2024, 6, 235
[3] Sul ruolo essenziale della parificazione (regionale) sul ciclo di bilancio, S. R. contr. 14 aprile 2022, n. 5/QM,, in Riv. C. Conti 2022, 2, 142, con commento di P. Santoro, La parificazione dei rendiconti regionali tra controllo e giurisdizione diventa conflittuale, ivi 2022, 2, 5; M. Pieroni, Il giudizio di parificazione del rendiconto generale e la legittimazione della Corte dei conti a sollevare questione di costituzionalità in tale sede, in D. De Pretis e C. Padula, Questioni aperte tra Stato e regioni, Torino, 281.
[4] Amplius, P. Santoro, Trattato di contabilità e finanza pubblica Giappichalli 2024, 1662 e 1693.
[5] Il c.d. “Diritto vivente» costituisce un sintagma utilizzato in diversi contesti ed in differenti accezioni, per indicare – in estrema sintesi e con l’inesattezza del caso la communis opinio maturata nella giurisprudenza e nella dottrina in ordine al significato normativo da attribuire ad una determinata disposizione, in Profili di diritto vivente nelle giurisprudenza costituzionale, a cura di Salvato, in Studi Corte cost. febb. 2015.
[6] La Consulta ha segnalato (sent. 246/2021) l’esigenza di una precisa disciplina positiva dello svolgimento del procedimento di parifica dinanzi alla sezione regionale di controllo che risulterebbe funzionale, specialmente con riguardo all’attività istruttoria e al contraddittorio con le parti, a una migliore sincronizzazione
[7] In motivazione si dà atto (punto 3.3) che la cornice interpretativa trova riferimento nei principi della discusa sentenza C. cost. n. n. 184/2022 contenete un espresso richiamo al «potere del pubblico ministero contabile di agire in giudizio per la tutela degli interessi dell’intera collettività alla corretta gestione delle risorse pubbliche e, in specie, al potere di impugnare decisione che si ritenga lesiva dei citati interessi
[8] S. Buscema, Bilancio dello Stato, in Enc. dir., vol. V, Milano, 1959, 423.
[9] C. Bentivenga, Elementi di contabilità pubblica, Milano 1970, 320, esclude che possa avere alcun rilievo per la giurisdizionalità del procedimento di parifica, tanto è vero che spesso si dispongono variazioni sui bilanci già chiusi.
[10] Pres. Carlino. Giudizio parificazione rendiconto 2023.
[11] M. Dogliani, La Corte dei conti, garanzia costituzionale della verità dello stato della spesa pubblica, in Scritti per i 150 anni della Corte dei conti, a cura di Sfrecola, Roma, 2013, 33; U. Allegretti, Controllo finanziario e Corte dei conti: dall’unificazione nazionale alle attuali prospettive, in Riv. Aic, n. 1/2013, 2.
[12] L’art.108 Cost. garantisce l’indipendenza dei giudici speciali, mentre l’art. 100 Cost. garantisce l’indipendenza dell’istituto e dei suoi componenti nell’esercizio della funzione di controllo (Corte cost., n. 1/1967).
[13] Corte cost. n. 1/1967.
[14] M. Nardini, La “tutela degli equilibri di bilancio” delle Regioni nella sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale, alla luce dei nuovi articoli 81 e 119 della Costituzione (note a sentenza del 28 marzo 2012, n. 70), in Amm. camm. 2012.
[15] S.R. spec., n. 20/2021, G. Menegus, Ceci ce n’est pas une pipe », ovvero sulla “ritrovata” natura giurisdizionale del giudizio di parificazione, in Dir. conti, giugno 2022.
[16] S.R. contr. n. 5/2022. L. Giampaolino, Il giudizio di parifica dei rendiconti regionali, in Giust. amm., 2016, 3.
[17] Corte cost.. n. 253/2022
[18] S.R. contr., n. 7/2013, cit.
[19] Corte cost. nn. 89/2017, 274/2017, 49/2018,184/2022 e 233/2022.
[20] Corte cost., nn. 18/2029, n. 235/2021, 9/2024 e 39/2024.
[21] S.R. spec., n. 8/2023; sulla possibilità di denunciare i vizi competenziali incidenti sulla spesa.
[22] Sez. Campania, n. 217/2019, cit., che peraltro intende distinguere la parificazione dalla verificazione e assimila la parifica ad un giudizio di conto, poiché l’atto che chiude il giudizio “decide” sugli interessi sottostanti e diffusi al bilancio i quali necessitano di certezza.
[23] Corte cost., n. 129/1957 e n. 121/1966.
[24] Sez. riun. contr., n. 7/2013/Qm); S.R., spec.,. S.R. spec. n. 7/2022 e n. 15/2023.
[25] P. Santoro, Trattato di contabilità e finanza pubblica, cit, 1710; L. Sambucci, Corte costituzionale e giurisdizionalizzazione dei controlli della Corte dei conti: le insidie del centralismo finanziario e contabile. Nota a Corte costituzionale, sentenza n. 184 del 22 luglio 2022, in Forum quad cost. , gennaio 2023.
[26] Cass., S.U., n. 23072/2014.
[27] Relazione della Procura generale (A. Corsetti) in sede di inaugurazione a.g. 2025.
[28]P. Santoro, Gli interessi adespoti dal giudice delle leggi ai giudici contabili, in Contabilita-pubblica, giugno 2021.