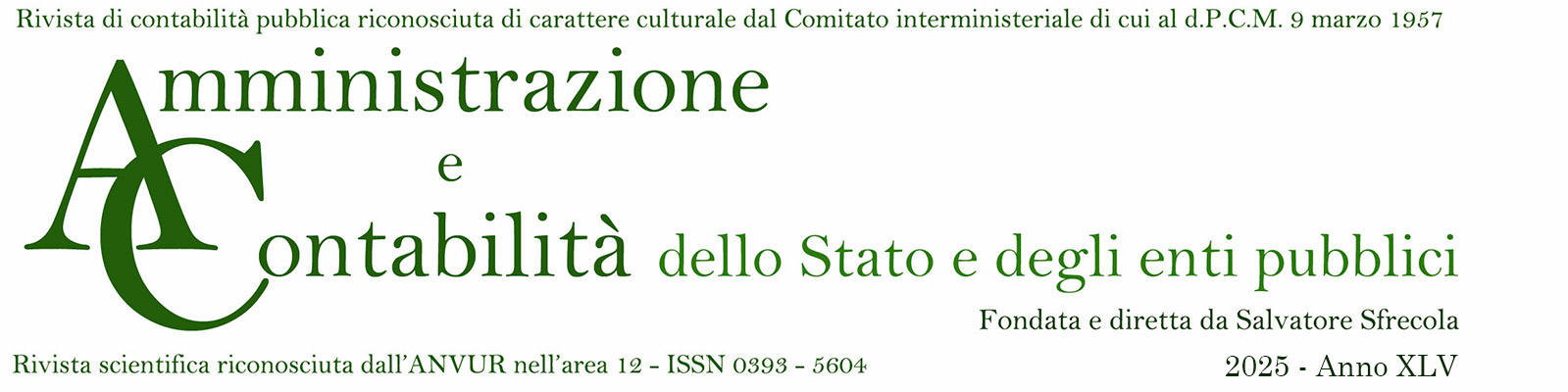di Pelino Santoro, Pres. on. della Corte dei conti
Torna alla ribalta del panorama giurisprudenziale delle Sezioni Riunite in speciale composizione la legittimazione del Procuratore regionale a impugnare la deliberazione del parifica del rendiconto regionale.
Il riconoscimento trova sostegno nella questione di massina riguardante la qualificazione quale procedimento di controllo (e non processuale) della parificazione dei rendiconti regionali che ha preso atto del “diritto vivente”, in base a cui la deliberazione/decisione assunta dalle Sezioni di controllo regionali è impugnabile ai sensi dell’art. 11, c. 6, lett. e), c.g.c.[1].
La pronuncia, disattendendo le eccezioni al riguardo formulate dalla difesa della parte resistente e dalla Procura generale, ha decisamente affermato l’ammissibilità e la procedibilità del ricorso presentato dal Procuratore regionale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Liguria, nel rispetto di quanto previsto dagli art. 123 e 124 c.g.c.; il Procuratore generale, sebbene etichettato come (parte necessaria interveniente (art. 127,comma 2, c.g.c.) non avrebbe alcun potere, nemmeno quello di rinunciare al ricorso; per la verità quest’ultimo profilo, trova un precedente della pronuncia delle stesse S.R in special composizione n. 20 del 2021, laddove affermava (punto7.4) che gli interessi per cui agisce il pubblico ministero sono pubblici e indisponibili, se non nei limiti e con le rigorose forme stabilite dal codice e nel caso del giudizio sui conti, che è un giudizio necessario, obbligatorio e di diritto obiettivo, la rinuncia agli atti, ovvero all’azione, non è ammissibile[2].
Se da un lato si rafforza la riconosciuta linea di “diritto vivente”, deve registrarsi una spaccatura all’interno dell’ufficio della Procura contabile, a livello regionale e generale/centrale.
La pronuncia s’inserisce in un contesto di non condivisione della decisione della Sezione di controllo che nell’esercizio dei suoi poteri decisori aveva ritenuto insussistenti i requisiti di ammissibilità di rilevanza e non manifesta infondatezza di una questione di costituzionalità proposta dalla Procura regionale.
Per comprendere le ragioni della spaccatura è bene fare il punto sulla posizione del p.m. contabile nell’area del controllo, quale si è venuta delineando dopo la riforma del d.l. n. 174/2012
La presenza del P.M. è contemplata, da sempre, solo nel giudizio di parificazione, quale elemento della formalità giurisdizionale sotto il profilo di un contraddittorio informale[3] che vede coinvolto il pubblico ministero contabile a tutela dell’interesse generale oggettivo della regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale dell’ente territoriale[4]; la sua funzione, tuttavia, è sbilanciata quasi esclusivamente sulla relazione che accompagna il rendiconto quale osservatore della legalità finanziaria, che segnala non solo i fenomeni di scostamento delle gestioni pubbliche dai parametri di legittimità e di regolarità, ma anche le criticità e la diffusione di eventuali patologie economiche e amministrative in settori della spesa regionale particolarmente sensibili[5].
Con il codice di giustizia contabile la giurisdizione in “unico grado”, esclusiva e piena (art 11, comma 6, c.g.c.), è caratterizzata dalla presenza necessaria del Pubblico ministero contabile, il quale sta in giudizio quale aggregatore degli interessi adespoti al bilancio dei cittadini, oltre che come rappresentante dello Stato ordinamento, nella sua triplice unità: giuridica, finanziaria ed economica[6]; il P.M. interviene sempre a tutela dell’interesse generale e anche nei giudizi che si basano su una pregressa delibera della Sezione regionale di controllo, la sua presenza ha natura sostanziale[7],
Per la dottrina, il P.M. contabile incarna, in quella sede, l’interesse della collettività nella sua massima espressione e più ampia estensione, a salvaguardia dello Stato-ordinamento sotto il profilo della legalità e dello Stato-comunità sotto il profilo degli interessi tutelati, ma soprattutto sotto il profilo della salvaguardia degli equilibri della finanza pubblica c.d. allargata[8], quale garante del principio di legalità[9]; nell’area della responsabilità, in particolare, il procuratore contabile vigila per l’osservanza delle leggi, per la tutela cioè dello Stato e per la repressione dei danni erariali conseguenti ad illeciti amministrativi, ma non effettua un controllo diretto ad accertare se i provvedimenti delle autorità amministrative siano stati emanati con l’osservanza delle leggi e con il rispetto dei criteri della buona e regolare amministrazione. La legge non gli attribuisce l’amplissimo potere di svolgere indagini a propria discrezionalità in un ampio settore dell’amministrazione[10] e in ogni caso l’attività del procuratore non cui non può essere considerata come un’impropria attività di controllo generalizzata e permanente[11], né sarebbe ipotizzabile la titolarità di una generalizzata attività ispettiva[12].
In via di principio, nel procedimento di parifica, il Procuratore regionale è chiamato a valutare, dal suo peculiare punto di osservazione, i dati contabili e gli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria curata dai magistrati del controllo, in contraddittorio con la Regione, per verificarne lo scostamento o meno dai parametri di legittimità e regolarità e in modo da segnalare eventuali patologie economiche e amministrative, nel giudizio di parificazione, in particolare, è un interveniente necessario che, nello svolgimento della funzione a lui attribuita di osservatore qualificato della legalità finanziaria, è chiamato a segnalare le illegittimità e le irregolarità rilevate nelle gestioni amministrative regionali e, non di meno, i fenomeni patologici che interessano i diversi settori della spesa dell’ente territoriale.
In tale ruolo, quale parte interveniente a tutela dell’interesse generale oggettivo della regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale dell’ente territoriale, il p.m. contabile è legittimato (quanto meno) a sollevare (id est proporre) questioni di costituzionalità di fonti normative regionali suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economici-finanziari dell’Ente territoriale.
Per la Corte regolatrice, nel giudizio di parifica le posizioni processuali del P.M. contabile e dell’amministrazione sono formalmente uguali, non essendo riconosciuto a nessuna delle due parti alcun potere di impulso processuale né di definizione o ampliamento dell’oggetto del giudizio, il cui dominus è esclusivamente la sezione di controllo attraverso la propria deliberazione, il p.m. interviene nel giudizio solo come mero organo di garanzia[13].
Per consentire l’esercizio della funzione di garanzia dell’ordinamento intestata alla procura regionale nella requisitoria del giudizio di parificazione, le Sezioni di controllo mettono a disposizione delle procure regionali i dati e i documenti contabili acquisiti[14].
Nei giudizi in unico grado contro le delibere di controllo, invece, il P.M. assume il ruolo di parte soltanto formale, e nondimeno necessaria, nell’interesse generale dello Stato-ordinamento e, in quanto tale, diversa dalle altre parti in causa[15].
Nella pronuncia delle S.R. n. 44/2017, si è riconosciuto, per la prima volta, l’interesse a ricorrere contro le deliberazioni di parifica a livello regionale, la cui lesività potrebbe derivare dal non corretto esercizio della funzione, nel senso che l’anomalo esercizio potrebbe ledere sia l’interesse (protetto) dell’ente a ottenere una pronuncia certativa sui conti nel quadro dei percorsi di approvazione normativa degli stessi sia l’interesse pubblico generale alla regolarità della gestione finanziaria, nel rilievo che assume la parifica quale strumento di garanzia della correttezza delle esposizioni contabili, in un’ottica ausiliaria rispetto alle decisioni politiche di approvazione con legge del rendiconto; a tali fini il pubblico ministero, nella specificità del giudizio di parifica, assume un ruolo sostanziale, che va oltre quello regolamentare attribuitogli di “interveniente necessario” in giudizi promossi da altri[16], la base giuridica è ravvisata nel riconoscimento da parte della Consulta
della peculiare autonomia e legittimazione dei Procuratori regionali, che vengono qualificati come ‘parti’ nei giudizi di parifica a quibus[17].
Secondo la procura generale il ricorso del procuratore regionale è inammissibile (ovvero improcedibile) per patente violazione del principio dell’unicità dell’Ufficio del Pubblico Ministero, sulla base dell’art 12 c.g.c. secondo cui il procuratore generale coordina, anche dirimendo eventuali conflitti di competenza, l’attività dei procuratori regionali e dei magistrati assegnati ai loro uffici; il presupposto del coordinamento, infatti, non può essere l’unicità dell’ufficio PM. anche perché, il comma 2 stabilisce che le funzioni di pubblico ministero innanzi alle Sezioni riunite e alle sezioni giurisdizionali d’appello spettano al Procuratore generale.
Diversamente opinando, ossia se l’ufficio del PM non fosse unico, la norma dovrebbe prevedere la partecipazione di ogni procuratore regionale ai giudizi che lo riguardano anche dinanzi alle magistrature superiori.
Il ricorso sarebbe inammissibile anche per la ragione che la parificazione del rendiconto generale (che sia dello Stato o della Regione) è un procedimento esclusivamente ascrivibile alla funzione del controllo, che nulla ha a che vedere con l’attività giurisdizionale e che trova i riferimenti normativi nel parametro 100, secondo comma, della Costituzione e negli articoli 39, 40 e 41 del r . d 1214 del 1934.
La tesi della Procura generale trova riscontro in quanto affermato in sede di inaugurazione dell’a.g. 2025, laddove si riconosce, a supporto della tesi dell’impugnazione del procuratore regionale , che la linea della unicità funzionale, troverebbe riscontro anche nella, questione di massina n. 34/2024/QM, laddove hanno precisato che «la limitazione legislativa alle sole “formalità della sua giurisdizione contenziosa” comporta che la deliberazione venga assunta previa trattazione in udienza pubblica, con la “partecipazione” del pubblico ministero, in contraddittorio dei rappresentanti dell’amministrazione, con ciò ammettendo che il contraddittorio è con i rappresentanti dell’Amministrazione e non pure con il P.M., il quale partecipa all’udienza pubblica senza essere parte in senso sostanziale.
Logico corollario è la carenza del potere di impugnativa della decisione di parifica da parte del P.M.[18].
A livello territoriale, è stato pure rilevato, come risulti del tutto singolare che, nell’ambito di un controllo tradizionalmente e strutturalmente radicato in seno alla Sezione di controllo si riservi la possibilità di intervenire a tutela di una generica finalità di tutela della legge ad un soggetto, come il Pubblico Ministero, che ordinariamente svolge un’altra funzione per la quale risulta, con un atto di impugnazione che lo trasforma in una parte contrapposta alla Sezione, un soggetto che non ha operato direttamente nell’istruttoria ed è semplicemente intervenuto nell’ambito di un procedimento di controllo alla cui istruttoria ha collaborato[19]; l’impugnazione autonoma da parte della Procura, peraltro, esporrebbe la Regione interessata, al di la del positivo contraddittorio collaborativo, ad una fase controversia dai contenuti più disparati, sol perché proposto nell’interesse della legge.
L’organo requirente, infatti, partecipa all’udienza di parificazione e al percorso propedeutico a essa, nell’ambito di un rapporto di “costruttiva e reciproca collaborazione tra i due uffici” di controllo e di procura, “in coerenza con la rispettiva autonomia di competenza, valutativa e decisionale”, e ciò allo scopo di rendere funzionale e, nel contempo, aderente all’oggetto della parifica fissata nell’art. 39 r.d. n. 1214/1934, l’intervento del procuratore regionale, come sottolineato dal giudice delle leggi[20].
E’ il caso di osservare, per quanto, ci riguarda che l’introduzione di un autonomo potere del (solo) procuratore regionale, lo configurerebbe come un super censore e fittiziamente in una parte sostanziale, né il procuratore regionale può atteggiarsi a “promotore di giustizia” come pure si è tentato di fare nella fase storica della riforma del 1994[21].
Il giudizio di parifica, ancorchè ricondotto a una configurazione esclusivamente di controllo, preserverebbe la sua atipicità di ordine processuale, poiché la presenza in giudizio del p.m. contabile gli garantirebbe una doppia legittimazione: quella come interveniente necessario nel procedimento di parifica[22] e quello di parte legittimata ad impugnare la delibera di parifica[23].
Il procuratore regionale, tuttavia, resta un interveniente ex lege, e non assume la qualifica di parte, sebbene si riconosca che nell’esercizio delle sue funzioni in materia di responsabilità il pubblico ministero contabile è una parte imparziale a tutela di interessi generali e indifferenziati dell’ordinamento; invece, quando promuove l’azione, infatti, agisce nell’esercizio di una funzione obiettiva e neutrale, in rappresentanza dello Stato-comunità nei suoi aspetti unitari, per assicurare l’integrità dell’erario globalmente inteso e l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione; l’azione della procura erariale, quale garante della legalità finanziaria nell’interesse dello Stato comunità, oltre alle finalità risarcitorie e di ristoro del danno erariale subito dall’amministrazione, costituisce anche strumento di tutela del corretto impiego delle risorse finanziarie e patrimoniali pubbliche attraverso la deterrenza avverso eventuali comportamenti devianti rispetto ai parametri dell’efficienza, efficacia ed economicità[24].
Nel giudizio di parifica, tuttavia, pur essendo possibile indicare quali “parti”, sia l’ente sia il pubblico ministero, si riconosce che il concetto di parte non è sorretto da alcuna norma procedimentale e può essere desunto solo in applicazione dei principi generali e sulla base della titolarità dei diritti tutelati[25].
Per di più deve registrarsi una differenziazione tra procura regionale e procura generale, dal momento che negli eventuali giudizi di costituzionalità sollevati in sede di parifica, è ritenuto ammissibile solo l’intervento del procuratore regionale, in quanto soggetto parte nel giudizio a quo[26], a meno che sia egli stesso parte del giudizio[27]; tale preclusione, tuttavia, opera anche nei giudizi di responsabilità, essendo consolidato l’indirizzo che, nonostante al pubblico ministero debba riconoscersi la qualità di parte nel processo a quo, da un lato la peculiarità della sua posizione ordinamentale e processuale, dall’altro l’attuale disciplina (articoli 20, 23 e 25 l. n. 87/1953 e seg.), tiene distinti il “pubblico ministero” e le “parti”, inducono ad escludere la costituzione nel giudizio di costituzionalità del procuratore regi[28].
Al di là del rigorismo di bandiera e del palese conflitto tutto interno all’ufficio del pubblico ministero contabile, la vicenda consolida la convinzione dell’assurdità giuridica di un ricorso oppositivo di un organo interveniente, in funzione collaborativa, nello svolgimento di un procedimento ausiliare all’assemblea legislativa, tanto più che il conseguente ritardo altera il “ciclo di bilancio”,[29] con evidenti ripercussioni sulla certezza dei conti pubblici, perché genera confusione contabile in considerazione del fatto che l’eventuale ricalcolo del “nuovo” risultato di amministrazione si riverbera a cascata, per effetto del principio di continuità, sugli esercizi successivi, sconvolgendone gli equilibri[30].
Va considerato, peraltro, che l’approvazione del rendiconto regionale soggiace a una rigorosa tempistica essendo stabilito che le regioni approvano il rendiconto entro il 31 luglio dell’anno successivo, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 aprile, per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (art. 18, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 118/2011), quale passaggio obbligato della successiva approvazione legislativa[31].
In conclusione la vicenda ultima, dovrebbe convincere che il tempestivo esito della parifica non può essere pregiudicato dall’atteggiamento, a volte puntiglioso, dei procuratori regionali che hanno già attivamente collaborato alla validazione e alla valutazione di attendibilità del saldo finanziario, nonché ai contenuti della relazione refertuale allegata.
Un’ultima considerazione riguarda il diverso regime processuale delle parifiche regionali rispetto a quella dello Stato, per la opera l’antico principio che la pronuncia di parifica è definitiva ed insindacabile e viene trasmessa direttamente al Parlamento (o, rispettivamente, all’Assemblea regionale), accompagnata da una relazione motivata, affinché quegli organi siano chiamati ad approvare i rendiconti senza peraltro ingerirsi nel riscontro giuridico espletato dalla Corte dei conti[32].
Nel quadro descritto la chiusura ermeneutica della Sezioni riunite sull’autodeterminazione processuale del Procuratore generale, riecheggia la famosa legge di Gresham che all’epoca del sistema monetario a base aurea dimostrava che la moneta scaccia la buona.
[1] S.R. giur., 11 dicembre 2023, n. 34/QM, in Riv. C. conti 2024,6, 235, con nota di P. Santoro, Il giudizio di parificazione allo specchio. Le due verità.
[2] Va osservato che il precedente citato faceva leva sulla (superata equiparazione giudizio di parifica a un giudizio di conto e per di più riguarda il famoso caso della Regione Sicilia, il cui contenzioso era stato innescato dal mancato accoglimento della istanza di mera correzione della deliberazione carente della intestazione di sentenza in nome del popolo italiano. In ogni caso il nuovo codice, riconosce espressamente (art. 110, comma 2) che il P.M., può, anche con dichiarazione in udienza rinunciare motivatamente agli atti del processo e che la rinuncia produce effetti solo dopo l’accettazione fatta dalla controparte.
[3] S.R.spec, n. 4/2024, ha ritenuto imprescindibile una valida forma di contraddittorio con il procuratore regionale; E. Tomassini, La decisione di parifica e l’inquadramento del procedimento da seguire: le Sezioni riunite in speciale composizione applicano le norme processuali e le conseguenti sanzioni anche alla fase di controllo, in Riv. C. conti, 2024, 3, 181.
[4] Corte cost., 22 marzo 2017, n. 89. S.R. contr., 14 giugno 2013, n. 7 (linee guida), in Riv. C. conti 2013, 3-4, 6. S. Buscema, di Trattato contabilità pubblica, vol. II, cit., 792.
[5] P. Santoro, Trattato di contabilità e finanza pubblica, Torino 2024, 1662.
[6] S.R. spec, 19 giugno 2020, n. 17.
[7] S.R. spec., n. 26/2016; si esclude invece che la Sezione regionale opposta possa assumere la qualità di parte nel giudizio sul ricorso contro l’atto adottato (S.R. spec. n. 12/2013. n. 3/2013 e n. 5/2013) .
[8] D. Morgante, La posizione del Pubblico Ministero contabile nel giudizio di parificazione del rendiconto, in Riv. C. conti, 2019, 2, 62; G. Bottino, IL ruolo del Pubblico ministero nei giudizi dinanzi alle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, Studi in memoria di Garri, aprile 2021, atti, 109.
[9] A. Police, Il ruolo del Pubblico Ministero nel giudizio di parifica dei rendiconti regionali tra giurisprudenza costituzionale e diritto eurounitario, in Studi in memoria di Garri, cit.; A. Morrone, Funzione di parifica e incidente di costituzionalità, Relazione Convegno “Il giudizio sui bilanci delle Regioni a statuto ordinario” (Bologna, 2 marzo 2021).
[10] Corte cost. n. 104/1989. A. Brancasi, Sul potere d’inchiesta della procura generale della corte dei conti, in Le Regioni 1990, 4, 1083.
[11] Corte cost. n. 209/1994 e n. 100/1995.
[12][12] Corte cost. n. 337/2005.
[13] Cass., S.U., n. 23072/2014 e n. 22645/2016, concordano nell’escludere la natura giurisdizionale, precisando che non è atto amministrativo.
[14] S.R. contr., n. 7/2013, cit.
[15] S.R. spec., 24 marzo 2014, n. 5; per la Regione, invece, l’interesse consiste in un esercizio dell’istituto della parifica che realizzi la funzione ausiliaria per cui è preordinato; un interesse che permane, dunque, fintantoché l’assemblea legislativa della regione stessa, nell’esercizio delle sue prerogative autonomamente esercitabili, approvi con legge il rendiconto regionale (S.R. spec., 27 /2014, cit.).
[16] S.R. spec., 15 dicembre 2017, n. 44, in Riv. C. conti 2017, 5, 269.
[17] Corte cost. n. 184/2022.
[18] Relazione a. g . 2025 (A Corsetti).
[19] E. Pesel, Il procedimento di parifica, Intervento all’incontro di studi presso il Seminario di controllo su Tecniche istruttorie nella parificazione del rendiconto regionale e tutela contraddittorio, Roma. 26 febbraio 2025
[20] Corte cost., n. 72/2012.
[21] Il primo d.l n. 54/1993 (non convertito) aveva introdotto l’azione a tutela della legittimità amministrativa, prevedendo che il procuratore regionalepotesse, in via autonoma, proporre ricorso innanzi al Tar avvero atti e provvedimenti delle p.a. in vista dell’interesse generale al buon andamento e all’imparzialità di esse, a tutela della legittimità dell’azione amministrativa e potesse resistere e intervenire nei giudizi pendenti.
[22] S. Buscema, Trattato di contabilità pubblica, vol. II, , 792, considerava l’intervento del Procuratore rimarrebbe “puramente formale e non sostanziale”, riducendo la presenza del P.M. ad una partecipazione “richiesta unicamente per giustificare le formalità della giurisdizione.
[23] D. Morgante, La posizione del Pubblico Ministero contabile nel giudizio di parificazione del rendiconto, cit.; G. Bottino, op. cit; A. Police, cit..
[24] Corte cost. n. 211/1972 e n. 104/1989.
[25] A Buscema, Il giudizio di parificazione per lo Stato e gli altri enti pubblici: evoluzione giurisprudenziale e prospettive, in atti Convegno Perugia 1884 sulla Giurisdizione, in Amm. cont. n. 4/1986, 232, osservava che i. Procuratore generale non interferiva in alcun modo nell’esercizio delle funzione di controllo, mentre ben altro significato a assumeva quando insieme al rendiconto generale venivano esaminati conti giudiziali dei tesorieri,
[26] Corte cost. n. 1/2024 seguita da sent. nn 9 e 39/2024.
[27] Corte cost., n. 184/2022, aveva riconosciuto una sorta di potere surrogatorio al p.m. dal momento che l’esito era suscettibile di incidere sul potere del pubblico ministero contabile di agire in giudizio per la tutela degli interessi dell’intera collettività alla corretta gestione delle risorse pubbliche e, in specie, sul potere di impugnare la decisione di parificazione del rendiconto generale regionale. Linea questa criticata da L. Sambucci Corte costituzionale e giurisdizionalizzazione dei controlli della Corte dei conti: le insidie del centralismo finanziario e contabile, cit.
[28] Corte cost., n. 123/2023. P. Principato, La presenza del pubblico ministero contabile nel giudizio costituzionale, in Dir. conti, n. 2/2024.
[29] Sul ruolo essenziale della parificazione (regionale) sul ciclo di bilancio, S. R. contr. 14 aprile 2022, n. 5/QM,, in Riv. C. Conti 2022, 2, 142, con commento di P. Santoro, La parificazione dei rendiconti regionali tra controllo e giurisdizione diventa conflittuale, ivi 2022, 2, 5; M. Pieroni, Il giudizio di parificazione del rendiconto generale e la legittimazione della Corte dei conti a sollevare questione di costituzionalità in tale sede, in D. De Pretis e C. Padula, Questioni aperte tra Stato e regioni, Torino, 281.
[30] Corte cost. n. 89/2017, n. 49/2018 e n. 39/2024. L. Sambucci, Corte costituzionale e giurisdizionalizzazione dei controlli della Corte dei conti: le insidie del centralismo finanziario e contabile. Nota a Corte cost., 22 luglio 2022, n. 184, in Forum quad. cost., genn2023; P. Santoro, Trattato di contabilità e finanza pubblica, cit., 1710; id.,Il giudizio di parificazione allo specchio. Le due verità, in Riv. C. conti 2024, 6, 235.
[31] L’eventuale ritardo nell’approvazione della proposta di legge è sanzionato (art. 9, comma 1-sexies, d.l. n. 113/2016 conv. l. n. 160/2013) con il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
[32] . Corte cost., n. 121/1966, e n. 165/196